| | | OFFLINE | Post: 11.290 | Registrato il: 03/10/2008
Registrato il: 01/11/2008 | Sesso: Maschile | |
|
Storie di conversione: Clive Staples Lewis Gli incontri pericolosi di un giovane ateo di Andrea Monda "Tutto solo in quella stanza di Magdalen, avvertivo su di me, una notte dopo l'altra, ogniqualvolta la mia mente si distraeva anche un attimo dal lavoro, la ferma, inesorabile stretta di Colui che mi rifiutavo ostinatamente di conoscere. Ciò che avevo più temuto si era alla fine impadronito di me. Durante il trimestre della trinità del 1929 mi arresi, ammisi che Dio era Dio e mi inginocchiai per pregare: fui forse, quella sera, il convertito più disperato e riluttante d'Inghilterra". "Tutto solo in quella stanza di Magdalen, avvertivo su di me, una notte dopo l'altra, ogniqualvolta la mia mente si distraeva anche un attimo dal lavoro, la ferma, inesorabile stretta di Colui che mi rifiutavo ostinatamente di conoscere. Ciò che avevo più temuto si era alla fine impadronito di me. Durante il trimestre della trinità del 1929 mi arresi, ammisi che Dio era Dio e mi inginocchiai per pregare: fui forse, quella sera, il convertito più disperato e riluttante d'Inghilterra".
Chi parla è Clive Staples Lewis, per gli amici semplicemente Jack, un professore di filologia di Oxford, di famiglia anglo-irlandese di Belfast, nato trentuno anni prima il quale, dopo un'infanzia "blandamente cristiana", si era buttato anima e corpo in un ateismo razionalistico e idealistico professato e vissuto.
L'intelligenza del giovane Jack è sottile, la sua curiosità sconfinata, l'acume fulminante, la forza dialettica eccezionale, ma qualcos'altro entra in ballo a sconquassare la sua apparentemente compatta fede nell'inesistenza di Dio, perché nella vita c'è sempre qualcos'altro, qualcosa di imprevisto, inavvertito, sorprendente.
Sorpreso dalla Gioia è forse il più bel titolo che si possa dare a un libro che racconti la storia di una conversione ed è quello che Lewis ha scelto per la sua autobiografia, scritta a cinquantasette anni ma relativa soltanto ai suoi primi trent'anni, perché, scrive nella prefazione: "Non ho mai letto un'autobiografia in cui la parte dedicata ai primi anni non fosse di gran lunga la più interessante".
Nel 1955 la passione di Lewis per i primi anni della vita degli uomini era una scelta naturale, quasi "obbligata": proprio in quegli anni stava finendo di pubblicare i sette episodi delle Cronache di Narnia, l'opera letteraria che, insieme alle Lettere di Berlicche, lo consacrerà come uno degli autori più letti e conosciuti in tutto il mondo (oscurando peraltro le sue pregevoli ricerche filologiche dedicate alla letteratura anglosassone medioevale).
Anche questi suoi celebri romanzi di pura fantasia hanno al centro il tema della giovinezza e della conversione. In una pagina di Mere Christianity Lewis parla di un ragazzo "emblematico", che chiama Dick, e scrive alcune parole che potrebbero essere prese come il riassunto della saga di Narnia: "Per quanto ne sappiamo, a Dio non costa nulla creare cose belle; ma convertire delle volontà ribelli gli costa la crocifissione (...) fino a quando Dick non si volgerà a Dio, penserà che il suo buon carattere sia una cosa sua, e fino che lo penserà, esso non gli apparterrà. Solo quando Dick capirà che il buon carattere non è una cosa sua ma è un dono di Dio, e solo quando lo offrirà di ritorno a Dio, esso comincerà ad essere veramente suo, perché allora Dick comincerà a partecipare alla sua propria creazione. Le sole cose che possiamo tenere sono quelle che diamo liberamente a Dio; quello che cerchiamo di tenere per noi è proprio ciò che sicuramente perderemo". Dick non è solo Edmund, il ragazzino per cui il leone Aslan si sacrifica lasciandosi uccidere nel secondo episodio di Narnia; Dick è, ovviamente, Jack.
Per dirla con le parole di Bonhoeffer la storia della conversione di Lewis raccontata in Sorpreso dalla Gioia è una storia di resistenza e resa. Da questo punto di vista il libro può essere visto come un diario in cui lo scrittore appunta i movimenti del suo animo scosso, avvinto e poi finalmente vinto dall'assalto di Dio, un diario della Gioia (è questo il "nome" di Dio secondo Lewis) a cui farà seguito sei anni dopo il brevissimo e intensissimo Diario di un dolore scritto a seguito della morte della moglie (che, guarda caso, si chiama Joy).
Scrive Lewis a metà della sua autobiografia: "Agnostici di buona volontà parleranno allegramente della "ricerca di Dio da parte dell'uomo"", ma Lewis non è (più) un agnostico di buona volontà, e non parla più "allegramente" perché ha sperimentato "l'inesorabile stretta" di Dio, e quanto può essere terribile la sua bellezza e la sua gioia. Sono queste due le polarità su cui si gioca l'intera esistenza di Jack, la Bellezza e il suo frutto, la Gioia, "... cioè un desiderio inappagato che è esso stesso più desiderabile di qualsiasi appagamento. Io lo chiamo gioia, che è qui un termine tecnico e va nettamente distinto dalla felicità così come dal piacere. La gioia (nel senso che io le attribuisco) ha in realtà in comune con essi una caratteristica, e una sola; il fatto che chiunque l'abbia provata vorrà provarla nuovamente. A parte questo, e solo in base alla sua natura, potremmo anche considerarla una infelicità o un dolore di genere particolare. Ma di un genere che desideriamo. Dubito che chiunque l'abbia sperimentata la scambierebbe mai, ammesso che fosse in suo potere, con tutti i piaceri del mondo. Ma, mentre il piacere lo è spesso, la gioia non è mai in nostro potere".
Alla luce di questa idea di gioia, così commista al dolore, si intuisce la profondità dell'immagine di Aslan, il divino leone protagonista delle Cronache di Narnia, una delle più sorprendenti figure cristologiche della letteratura novecentesca. Aslan, figura a un tempo del Dio creatore e del Cristo redentore che si sacrifica per amore, è un leone, buono e maestoso, dolce e terribile, perché per Lewis Dio è un leone che si mette alla ricerca dell'uomo, che lo bracca e lo abbraccia. "In realtà, un giovane ateo non ha modo di proteggere la propria fede come si deve" confessa in Sorpreso dalla Gioia, "I pericoli lo assediano da ogni parte".
Un permanente stato d'assedio, ecco cos'è la vita per lo scrittore inglese, un assalto che paradossalmente esalta l'umiltà di Dio che, come il padre del figliol prodigo va alla ricerca di tutti, anche di colui che cerca di sfuggire al suo abbraccio: "Allora non mi avvidi di quello che oggi è così chiaro e lampante: l'umiltà con cui Dio è pronto ad accogliere un convertito anche a queste condizioni. Per lo meno, il figliol prodigo era tornato a casa coi suoi stessi piedi. Ma chi potrà mai adorare adeguatamente quell'amore che schiude i cancelli del cielo a un prodigo che recalcitra e si dibatte, e ruota intorno gli occhi risentito in cerca di scampo? (...) La durezza di Dio è più mite della dolcezza umana, e le Sue costrizioni sono la nostra liberazione".
Un luogo pericoloso è il mondo, soprattutto per chi voglia mantenere incorrotta la sua incredulità e voglia impedire a Dio questo processo di liberazione. E Lewis li enumera tutti questi pericoli che hanno attentato e poi minato alle radici il suo ateismo: la bellezza della natura e dell'arte, il dono della gioia che la vita ci regala in maniera sempre improvvisa e imprevista, e poi l'incontro con gli altri uomini, quelli reali, conosciuti fisicamente e quelli incontrati attraverso la mediazione della lettura dei libri.
Tra i tanti di questi "incontri pericolosi", vale la pena citarne tre che giocheranno un ruolo determinante nel cammino di conversione dello scrittore inglese: Chesterton, MacDonald e Tolkien. "Nel leggere Chesterton, come nel leggere MacDonald, non sapevo a cosa andavo incontro" scrive in Sorpreso dalla Gioia, "Un giovanotto che desidera rimanere un perfetto ateo non può andare troppo per il sottile nelle sue letture. Ci sono trabocchetti sparsi dappertutto: "Bibbie lasciate aperte, milioni di sorprese" come dice Herbert, "reti sottili e stratagemmi". Dio è, se così possiamo dire, pochissimo scrupoloso".
Saranno proprio i libri di Chesterton (in particolare L'uomo eterno) e quelli di MacDonald (in particolare Le fate dell'ombra) che "prepareranno" il giovane Jack alla "capitolazione" che però avverrà solo con il colpo finale assestato dall'incontro con Tolkien. I due si conosceranno alla fine degli anni Venti a Oxford, entrambi innamorati delle antiche saghe e leggende, e tra loro nascerà un'amicizia di oltre quaranta anni da cui poi scaturirà la nascita di quei romanzi che oggi tutto il mondo conosce, Narnia e Il Signore degli Anelli.
Se nel 1929 Jack si era inginocchiato e aveva pregato Dio in modo disperato e riluttante, l'amicizia di Tolkien lo portò all'incontro con Cristo. Il 19 settembre del 1931 Jack e Tollers (com'era chiamato dagli amici più intimi) insieme al comune amico Hugo Dyson, dopo cena, fanno la solita passeggiata sul parco del Magdalen College e incominciano a parlare di antichi miti e della Verità "nascosta" in quei racconti.
Finiranno a parlare oltre le tre del mattino e Lewis qualche giorno più tardi scriverà al suo vecchio amico Arthur Greeves: "Da poco sono passato dal credere in Dio al credere in maniera definitiva in Cristo, nel cristianesimo. Cercherò di spiegartelo un'altra volta. La mia lunga chiacchierata notturna con Dyson e Tolkien ha avuto una grossa parte in questo". Come Nicodemo anche l'intellettuale Lewis ha conosciuto la sua notte piena di luce e la sua vita è radicalmente cambiata. Da quel momento diventerà strenuo difensore della fede riconquistata e raffinato divulgatore della verità del cristianesimo: i suoi saggi sulla fede, sul dolore e sull'amore sono ancora oggi tra le opere più valide dell'apologetica cristiana del Novecento.
In questo senso la sua parabola ricorda proprio quella di Chesterton; anche se Lewis non riuscì mai a fare formalmente il passo per entrare nella Chiesa cattolica (ma sostanzialmente lo fece, tanti sono i segnali di questo suo cripto-cattolicesimo, non ultimo la sua splendida corrispondenza epistolare con san Giovanni Calabria) la sua storia, come quella dell'inventore di Padre Brown, è quella di un cuore e di un'intelligenza che si arrendono di fronte alla Gioia che scaturisce dalla Buona Novella e che spazza via tutte le fantasie e le elucubrazioni del razionalismo umano (cosa diversa dalla ragione, meraviglioso dono di Dio).
Chesterton passò al cattolicesimo nel 1922, qualche anno prima di Lewis e poté quindi regalarci due affermazioni che Jack avrebbe potuto sottoscrivere pienamente: la prima nel saggio La Chiesa cattolica e la conversione in cui ribadisce che "Il marchio della fede non è la tradizione: è la conversione. È il miracolo per cui gli uomini scoprono la verità nonostante la tradizione, e spesso a costo di strappare tutte le radici umane (...) Può darsi che tra un secolo o due saranno diventati una tradizione lo spiritismo, il socialismo e la Christian Science. Ma il cattolicesimo non sarà mai una tradizione. Sarà sempre una cosa scomoda, nuova e pericolosa", la seconda in versi poetici, scritti proprio in occasione del passaggio alla fede cattolica: "I saggi hanno cento mappe che disegnano universi fitti come alberi, scuotono la ragione con mille setacci che accantonano la sabbia e lasciano filtrare l'oro: per me tutto ciò vale meno della polvere perché il mio nome è Lazzaro e sono vivo".
(©L'Osservatore Romano - 7 - 8 luglio 2008) __________________________________________________
 |
| |
|
| |
| | | OFFLINE | Post: 11.290 | Registrato il: 03/10/2008
Registrato il: 01/11/2008 | Sesso: Maschile | |
|
Storie di conversione: Clemente Rebora
Il poeta che non trovò più le parole di Marco Testi
Nel 1928 Clemente Rebora teneva una conferenza sul cristianesimo, la prima di una serie sulle religioni, al Lyceum di Milano. Stava leggendo alcuni passi degli Atti dei martiri scillitani: arrivato al punto in cui i testimoni della fede, non accettando la clemenza del proconsole romano, scelgono di andare incontro alla morte, secondo il ricordo diretto di Margherita Marchione, "non poteva più andare avanti. (...). La vista gli si annebbiava. Qualche cosa gli stringeva la gola. Si prese la testa fra le mani. Si sentì smarrito. Non fu capace di proseguire". È l'apice della crisi, il momento del non ritorno, l'analogon della lettura dell'epistola ai Romani nelle Confessioni di Agostino. Il ricordo della scelta di morte-vita da parte di antichi testimoni della fede, diviene improcrastinabile e improvvisamente chiarissima percezione che quella scelta è necessaria anche per chi la sta ricordando. Il moderno lettore di memorie cristiane diviene, davanti a un pubblico esterrefatto, a sua volta testimone, scegliendo la morte (e il silenzio) alla vecchia vita, unica strada possibile per poter rinascere.
Il resto è storia nota: la comunione - e in un secondo momento la cresima - ricevuta nel 1929 dall'arcivescovo di Milano, il cardinale Schuster, cui Rebora scriverà più volte per manifestargli la sua gratitudine e il suo commosso ricordo, l'ingresso nel collegio Rosmini di Stresa nel 1930, l'inizio del noviziato a Domodossola l'anno dopo e poi l'ordinazione sacerdotale nel 1936.
Si farebbe torto, però, alla complessità del travaglio interiore del poeta milanese se si parlasse di conversione improvvisa, perché Clemente, appartenente a una famiglia imbevuta di ideali laici e risorgimentali e di frequentazione massonica, aveva già manifestato un'ansia latu sensu religiosa: "Nessuno di noi due era mai stato ateo, anzi vorrei dire che tutti e due eravamo sempre stati profondamente religiosi", scrive un suo antico sodale, Goffredo Pistoni. Il giovane autore dei Frammenti lirici, capo d'opera nel 1913 del moralismo vociano, ma allora incompresa e ignorata raccolta poetica, alle radici della scarnificazione ermetica di qualche anno più tardi, aveva iniziato da tempo un cammino spirituale, partendo dal deismo mazziniano di cui era imbevuta la severa moralità del padre. Però questa dirittura etica, condivisa certamente dal giovane poeta, lasciava aperti interrogativi laceranti in un'anima che recava già in sé le stigmate di una inquieta ricerca di senso. Non gli bastava, come ha scritto Renata Lollo, "una verità puramente speculativa". La stessa serietà nei rapporti familiari, lo stesso auto-controllo e la capacità di nascondere e dominare i sentimenti, cominciavano a stargli stretti.
"Io sto con Buddha Cristo Dante Bruno (veggansi gli heroici furori) Vico Alfieri e Leopardi; modestamente, secondo la mia statura. Non faccio professioni di fede che sarebbe inutile; io rispetto il tuo pensiero che ti ha potuto reggere sì maravigliosamente e come figlio non posso far altro. (...) Scusami se forse io abbia assunto un tono irrispettoso di polemica: guardami qui entro e mi potrai vedere tutto e forse anche come mi vorresti. Forse è sorte di chi tende al bene e a ideali oltre il comune, di apparir o pazzo o stravagante o giù di lì". È il brano di una lettera scritta da Clemente al padre, che gli rimproverava lo scarso controllo dei propri nervi, il 22 ottobre 1908: il giovane manifesta la volontà di cercare strade nuove e diverse dalla visione del mondo illuministica di cui era portatore il padre. Ma, come si vede, erano strade costellate di eclettismo e sincretismo, che avevano la funzione essenziale di portarlo fuori da quella sorta di immobilismo in cui si trovava in quel periodo.
In effetti, nella raccolta che seguì i Frammenti, Canti anonimi, uscita nel 1922, si nota la presenza di una nuova ricerca, perché quella situazione di scacco rischiava di portare all'aridità e alla morte: un po' come la disperazione e il nulla della Terra desolata di Eliot che preparano il Mercoledì delle ceneri della rinascita alla fede.
Dobbiamo però andare ancora più indietro, per capire fino in fondo quanto lunga e complessa sia stata la strada della conversione per Rebora, e più precisamente al momento in cui il poeta viene mandato al fronte. Clemente, che si era legato dal 1914 a Lydia Rivolta Natus, colta e sensibile donna di origine russa - l'amore per la donna e la guerra diverranno quasi un tutt'uno nei ricordi del Rebora sacerdote, come segno di morte dell'anima e del corpo - nel dicembre 1915 rimane sepolto sotto una frana causata dallo scoppio un obice da 305, esploso a due passi da lui. L'incidente gli causerà danni fisici e un trauma psichico che rimarrà per sempre impresso nella sua anima.
Non è un semplice evento di guerra, come migliaia in quei durissimi anni, ma per Rebora diviene segno e viatico di un destino: nel nosocomio di Bologna, uno psichiatra, colpito da alcune parole del poeta, diagnosticò una "manìa dell'eterno". Un segno dei tempi: da una parte la medicina ufficiale e il positivismo di metodo dell'Italia di primo Novecento, dall'altra un bisogno di nuovo respiro che veniva da molto lontano e che nell'incidente di guerra aveva avuto modo, tragicamente, di uscire allo scoperto.
Con la conversione, l'entrata in convento e il successivo silenzio, sembrano perdersi, secondo Contini, le tracce del Rebora poeta "espressionista". Da questo silenzio, che il poeta lombardo (ma di ascendenti liguri) si era coscientemente e rigorosamente auto-imposto, riemergono di quando in quando tracce poetiche: tra il 1946 e il '47 escono due nuove edizioni dei suoi versi e nel 1956 gli inediti Canti dell'infermità. Qualcosa non è andata persa di quella antica stagione, proprio quando il frate rosminiano scriveva per i confratelli poesie dedicate all'amore di Gesù per le feste comandate, per le occasioni d'incontro o per matrimoni, ma non di gente importante: una volta compose una poesia come dono di nozze per un cieco di guerra, su invito di una bambina. Inoltre, nell'approssimarsi del tramonto terreno del poeta è possibile rilevare profonde tracce dell'inizio, come in una lirica datata 13 gennaio 1956, nella quale si notano molti punti di contatto con la precedente produzione: "Tutto è al limite, imminente: / per lo schianto, basta un niente; / da un gran vuoto / tutto esorbita nel moto, / anime, famiglie, consorzi; / tutto è un farsi avanti a spinte e a sforzi: / sono contati gli istanti". Si penserebbe quasi al Rebora dei Frammenti lirici, se non fosse che più avanti si parla direttamente di Dio, e che c'è un richiamo alla propria vicenda: "Un che sa, ed è dei capi / (Nicodemo forse?) / scorta luce ove è Gesù, / all'oscuro s'inoltra, / e in segreto, a tu per tu, / chiede qualcosa di sicuro". Eccolo, il "vecchio" Rebora, poeta di talento, ma involto in una crisi senza apparente speranza: è il Nicodemo che si accosta nel segreto - quasi ancora dubitasse - a Gesù, e chiede una parola che lo traghetti al sicuro, dall'altra parte del guado.
Quello che è venuto dopo la conversione, non sembra più interessare i critici letterari, perché riguardava un uomo che rinunciava talvolta al canto, per comporre poesiuole di comunione e di Natale facili, rime che tutti, e non solo pochi intimi, potessero cantare nelle feste religiose.
Solo pochi hanno colto l'abissalità della scelta: il sacrificio del vecchio sé fino a farsi umile catechista, per diventare unicamente voce del Verbo. In occidente vi sono stati pochi esempi come questo. Aveva ragione Claudel: la spasmodica tensione che spinse l'ancor giovane Rimbaud verso il silenzio aveva anche dell'angelo, non solo del demone.
Eppure questa rinuncia sarebbe divenuta, in altri tempi o in altri luoghi, materia di costruzione di un mito. Ma sarebbe stato un mito troppo "sfacciatamente" religioso, in contrasto con la mitologia "laica" di quei tempi.
Che se ne fa la storia della letteratura di un poeta che apparentemente rinuncia al canto, quel canto che pure - ma molti anni dopo - lo avrebbe reso un mito del primo Novecento, indicato a dito dagli storici della letteratura come l'iniziatore della nuova "melica" insieme a Dino Campana? Che se ne fanno gli addetti ai lavori di un poeta che cita costantemente le Scritture nei suoi versi?
Eppure, se fossero stati più attenti, avrebbero trovato impressionanti episodi in cui il dolore dell'agnello sacrificale nella Bibbia, del Cristo nei vangeli e di Clemente nelle poesie del convento divenivano poeticamente una cosa sola, come in "Solo calcai il torchio", in cui il sacerdote sofferente fa accenno all' "incomprensibile amore del Padre", riprendendo fedelmente Isaia, 63, 3. In Rebora il racconto del re-vendemmiatore, che sconfigge i nemici di Israele senza l'aiuto del suo popolo caduto nel peccato è figura del Cristo patiens, ricoperto del suo sangue versato per gli uomini, e anche della sofferenza del poeta, che la offre come espiazione.
È evidente qui l'identificazione assoluta di Rebora nel Cristo sofferente, per cui ambedue possono affermare di aver sparso in libagione il loro sangue, Cristo per libera scelta, il poeta-sacerdote per l'infermità che lo sta sempre più avvicinando al Vivente. Una identificazione con l'agnello sacrificale che lo avvicina all'altra grande epopea incompresa del nostro Novecento, gli Orfici di Campana.
Resta il fatto di una poesia che continua anche dopo la conversione, spesso con soluzioni che ricordano i Frammenti. Nonostante l'aspirazione al silenzio, la voce ritorna. Nonostante il tentativo di mutarla, di disciplinarla nell'ubbidienza, nella regola, essa riprende il suo antico ruolo, solo che stavolta aveva trovato la sua strada: Dio e gli altri.
La grande crisi di identità dell'antico poeta era divenuta dono di sé in modi che l'uomo contemporaneo (con le dovute eccezioni: Giovanni Boine, Benjamin Crémieux, Jean Chuzeville e più tardi Carlo Betocchi) non poteva comprendere. Il poeta perduto aveva affrontato la solitaria strada dell'ineffabile, che lo avrebbe portato a distanze irreparabili dal suo vecchio uomo e, in taluni casi, anche dagli altri.
(©L'Osservatore Romano - 12 luglio 2008) __________________________________________________
 |
| |
| | | OFFLINE | Post: 11.290 | Registrato il: 03/10/2008
Registrato il: 01/11/2008 | Sesso: Maschile | |
|
Storie di conversione: il personaggio «C33» di Oscar Wilde
La gentilezza che spezza
il cuore di pietra di Antonio SpadaroQualcuno ricorderà L'Annuario del parroco, una bella raccolta di Testi e documenti di vita sacerdotale e di arte pastorale, curata al suo sorgere nel 1955 da don Giuseppe De Luca. In quelle pagine la vita sacerdotale veniva declinata con maestria con l'arte pastorale. La parola arte aveva il suo senso proprio e non era dunque solo una maschera dei termini, oggi più comuni, di tecnica o metodologia. Nel 1970, quando da sette anni l'Annuario era curato da don Giuseppe Badini, nella sezione "I pozzi delle anime" appare un brano dal titolo "Il posto di Cristo è veramente tra i poeti". Il suo autore è Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde, noto più comunemente come Oscar Wilde (1854-1900). È un testo tratto da quella lettera che va sotto il nome di De profundis. Perché don Badini cita questa lettera del "pagano" Wilde tra le letture possibili di un buon sacerdote?
Il De profundis, tra le più intense della produzione wildiana, è una lunga lettera a lord Alfred Douglas. Perché Wilde l'ha scritta? Per rispondere è necessario entrare almeno succintamente nella biografia dello scrittore. La vita di Wilde è definibile come "estetica", catturata dalla bellezza e dai suoi riflessi fascinosi. In fondo poi tutto, fino a un certo punto, andò bene nella sua esistenza: una brava e affettuosa moglie, due bambini, il successo. Ma non durò a lungo. L'affetto per la moglie era fin troppo spiritualizzato ed estetizzante per resistere. I luoghi dove il giovane Wilde, certe notti, si perdeva erano i bassifondi, dove andava alla ricerca di ragazzi sessualmente compiacenti. L'equilibrio creato non poteva durare a lungo e infatti si spezzò quando Wilde fece la conoscenza di lord Douglas. Quest'amicizia portò lo scrittore insieme all'esaltazione e alla rovina economica e morale. La parabola discendente giunse a portare Wilde in tribunale, giudicato e condannato per pederastia. Siamo nell'Inghilterra del 1895. Il mondo di Wilde, già uomo di successo, si capovolse.
Gli anni di carcere furono durissimi, confortati solo da qualche lettura, e tra queste quella di Dante, del Nuovo Testamento, dei Pensieri di Pascal, della Vita di Gesù di Renan. In questo contesto Wilde scrisse il De profundis, che si configura come il grido stesso dell'anima che dall'abisso della disfatta cerca di risalire alla luce: "Dalla mia natura sono venuti fuori una selvaggia disperazione, un abbandono al dolore pietoso da guardare, furore terribile e impotente, amarezza e sdegno, angoscia che piangeva a gran voce, infelicità che non riusciva a trovare sfogo, dolore muto. (...) non potevo sopportare che (le mie sofferenze) fossero senza significato. Ora trovo, nascosto da qualche parte della mia natura, qualcosa che mi dice che niente al mondo è senza significato, e meno di tutto la sofferenza". Cosa è capace di trasformare il "dolore muto" nella "bellezza del dolore"? La risposta si può trovare in un'opera di Wilde forse meno nota eppure strordinaria: The Ballad of Reading's Gaol (La ballata del carcere di Reading), un poemetto di 109 sestine scritto dopo la scarcerazione. Scontata la sua pena, Wilde si rifugia a Berneval, un paesino della Francia. Lì comincia a comporre l'opera che uscì esattamente 110 anni fa, nel 1898, dapprima anonima: il suo nome apparirà solo nella settima edizione fino alla quale l'autore si celò sotto i numeri della sua matricola carceraria "C33". Il protagonista è un uomo, di cui non viene fatto il nome, che aveva ucciso la donna che amava e che la legge ha giustiziato.
La Ballata si apre con l'immagine del condannato che cammina tra i carcerati con un triste abito grigio. In pochi tratti Wilde prosegue descrivendo tasselli e figure di vita carceraria, con straordinaria efficacia fino a descrivere quella "sete morbosa / Che ti insabbia la gola, prima / che il boia con i suoi guanti da giardiniere / Esca dalla porta imbottita / E ti leghi con tre corregge di cuoio, / Che la gola non provi sete mai più". Wilde percepisce il pianto, la "guancia che trema", la preghiera "a labbra di creta" mai fuori dallo sguardo altrui.
Viene il giorno dell'esecuzione della sentenza e l'autore riflette: "Come navi a bufera spinte / Incrociammo le rotte: / Segno o parola non facemmo, / Nulla c'era da dire; / Non la santa notte incontrammo, / Ma di vergogna il giorno". Non la santità aveva segnato il loro incontro, ma la vergogna, ciascuno nella sua cella, nel suo "inferno separato: il mondo ci aveva espulsi dal suo cuore, / E Dio dalla Sua cura". Il senso dell'abbandono vince la riflessione e le immagini luminose perché ci si scopre presi dalla "ferrea tagliola" del peccato, trapassati dalla sua spada "fino all'elsa avvelenata". La preghiera accompagna queste emozioni di tristezza e di angoscia ("Tutta notte pregammo inginocchiati"). L'orologio della prigione "Trafisse l'aria tremante" e "Al gancio di trave annerita / L'unta corda vedemmo, / La preghiera si udì che il laccio / In stridìo strangolò". Il cadavere, nudo e incatenato, "avvolto in un lenzuolo di fiamma", è ceduto alla calce che lo divora. Quel pezzo di terra sarà interdetto alla semina perché sconsacrato. Resterà sterile e spoglio perché in carcere pensano "che un cuore di assassino corromperebbe / Anche i loro semi innocenti". Ecco il "dolore muto", espressione di una condanna senza appello.
Ma a questo punto il grido di Wilde è incontenibile nel suo sdegno: "Non è vero! La terra di Dio è gentile", pietosa, migliore più di quanto la mente dell'uomo possa sapere o immaginare: "La rosa rossa potrebbe fiorirvi / più rossa ancora e più bianca la bianca". La Grazia ha percorsi insondabili e si manifesta proprio dove l'angoscia divora il cuore e il senso del peccato sembra non lasciar respiro. Alla "dolce aria di Dio", al raggio del suo sole potrebbe venire "Dalla bocca una rosa rossa! / Una bianca dal cuore!". Infatti "chi può dire per quali strane vie / Cristo porta alla luce la Sua volontà?". La via della Grazia può essere strana, insolita, ma viene comunicata dal fatto che "il Figlio di Dio è morto per tutti".
La "strana via" parte dalla Croce di Cristo, davanti alla quale la sofferenza senza senso e il "dolore muto" diventano grido di appello prima e poi di stupore per la salvezza che ricorda da vicino ciò che sant'Ignazio scrive nei suoi Esercizi Spirituali, dopo aver proposto la meditazione sul peccato: "Grido di stupore con profonda commozione, considerando che (...) la terra non si sia aperta per inghiottirmi, creando nuovi inferni per tormentarmi in essi per sempre" (n. 60). Si ha la netta percezione che la "gentilezza" della "terra di Dio" sia icona, immagine viva della salvezza.
Le leggi di Dio, quelle eterne, sono come la terra: gentili, clementi, buone a tal punto che spezzano il cuore di pietra. E questa frattura è la porta attraverso la quale Cristo può entrare nella vita di un uomo. Nessuna durezza può sbarrargli il passo: "Ogni cuore umano che si spezza / In cella o cortile di carcere, / È come l'anfora spezzata che rese / Il suo tesoro al Signore, / E colmò la casa del sudicio lebbroso / Del profumo del più prezioso nardo". Anche se di pietra, il cuore spezzato dalla Grazia è come l'anfora di nardo che nel Vangelo appare infranta per profumare i piedi di Cristo. E questo profumo stilla da un cuore di peccatore, anche da quello di un omicida. Allora, esclama Wilde, "Beati coloro il cui cuore può spezzarsi / E conquistare la pace del perdono!". Anzi, "Se non per il cuore spezzato / Come entrerebbe Cristo?". Il cuore spezzato è una condizione perché il vangelo e il perdono non scorrano via come su una superficie impermeabile.
Il carcere può diventare luogo di salvezza perché a contatto con il Cristo, la bruttura del peccato è tolta, e la "bellezza del dolore" si rivela. Ecco la conclusione e la risposta alla domanda che ponevamo all'inizio: il dolore "bello" è quello proveniente dalla commozione stupita che si ritrovano coloro il cui cuore è stato spezzato dalla gentilezza di Dio. Ecco "il centro motore dell'arte di Wilde": "L'uomo non può arrivare al cuor divino se non attraverso quel senso di separazione e di perdita che si chiama peccato" (James Joyce).
(©L'Osservatore Romano - 16 luglio 2008) __________________________________________________
 |
| |
| | | OFFLINE | Post: 11.290 | Registrato il: 03/10/2008
Registrato il: 01/11/2008 | Sesso: Maschile | |
|
Storie di conversione: da Agostino a Saulo
Contro l'abitudine la sfida più difficile di Gianfranco Ravasi
J'ai pleuré et j'ai cru: "ho pianto e ho creduto". Bastavano questi due verbi a Chateaubriand per descrivere nel suo Génie du Christianisme (1802) la conversione che dal razionalismo scettico l'aveva ricondotto alla fede dell'infanzia. Anche a Gesù nella sua prima, lapidaria predica pubblica erano stati sufficienti due verbi per scuotere la coscienza dei suoi uditori: Metanoèite kài pistèuete, "convertitevi e credete!" (Marco, 1, 15). Il verbo greco della conversione era significativo perché esigeva una sorta di torsione del noùs, ossia della mentalità che doveva optare per una nuova visione della vita e dell'essere (verbo e relativo sostantivo risuoneranno ben 56 volte nelle pagine neotestamentarie).
Più di taglio "spaziale", ma semanticamente analogo, era il termine che le Scritture ebraiche avevano selezionato: shûb, cioè "ritornare", invertendo la rotta sbagliata, vocabolo reso dall'antica versione biblica greca dei Settanta con un pregnante epistrofè, segno di una svolta radicale. E la mirabile parabola detta "del figlio prodigo" è quasi la sceneggiatura filmica di una perversione del percorso della vita e del "ritorno" in se stessi e verso la casa paterna lasciata prima alle spalle (si legga Luca, 15, 11-24).
 Alla galleria di ritratti di convertiti che il nostro giornale sta proponendo in questo periodo, vorremmo aggiungere, allora, una riflessione di carattere generale su un fenomeno che spesso ha inciso non solo sulla vicenda personale di molte persone, ma anche nella stessa storia dell'umanità. Certo, le conversioni hanno tipologie differenti e possono ricevere denominazioni antitetiche secondo le diverse prospettive: ci può essere, infatti, una conversione che è tale per i cristiani, ma diventa "apostasia" per un'altra confessione di fede. C'è anche la svolta politica che spesso, però, lascia una traccia di sospetto e può persino essere classificata sotto il termine realistico di "voltagabbana". C'è la trasformazione ideologica da una concezione filosofica a un'altra (in filosofia si ha anche il procedimento di "conversione logica", già illustrata da Aristotele). Alla galleria di ritratti di convertiti che il nostro giornale sta proponendo in questo periodo, vorremmo aggiungere, allora, una riflessione di carattere generale su un fenomeno che spesso ha inciso non solo sulla vicenda personale di molte persone, ma anche nella stessa storia dell'umanità. Certo, le conversioni hanno tipologie differenti e possono ricevere denominazioni antitetiche secondo le diverse prospettive: ci può essere, infatti, una conversione che è tale per i cristiani, ma diventa "apostasia" per un'altra confessione di fede. C'è anche la svolta politica che spesso, però, lascia una traccia di sospetto e può persino essere classificata sotto il termine realistico di "voltagabbana". C'è la trasformazione ideologica da una concezione filosofica a un'altra (in filosofia si ha anche il procedimento di "conversione logica", già illustrata da Aristotele).
Ma la "conversione" per eccellenza rimane quella religiosa. Essa può segnalare il transito dall'ateismo o dall'indifferenza agnostica all'accoglienza del divino e della trascendenza secondo un Credo particolare. Ma può anche essere la ripresa ardente di una fede smarrita o appannata dalla consuetudine: "La conversione più difficile - scriveva un autore spirituale, Louis Evély, nel saggio C'est toi cet homme - è quella a cui tutti siamo chiamati, all'interno della nostra religione".
Ed è interessante notare che uno dei più originali teologi del secolo scorso, di cui ebbi la fortuna di essere discepolo, il gesuita canadese Bernard Lonergan (1904-1984), nella sua opera Method in Theology (1972), considerava la triplice categoria della conversione - intellettuale, morale e religiosa - come strutturale nella stessa epistemologia teologica, secondo una gradazione progressiva d'orizzonte, ma anche secondo un intreccio indissolubile. Alla sorgente, comunque, della conversione religiosa c'è la teofania: è un atto esterno alla creatura che, attraverso mediazioni di vario genere, procede da Dio. È ciò che teologicamente è definito da san Paolo come "grazia", chàris in greco, da cui nasce la charitas latina, ossia l'atto d'amore divino.
Suggestiva è la frase dell'Apostolo che si stupisce lui stesso dell'asserto profetico su cui costruisce la sua dichiarazione: "Isaia arriva fino ad affermare: Mi sono fatto trovare (dice il Signore) anche da quelli che non mi cercavano: mi sono rivelato anche a quelli che non si rivolgevano a me" (Romani, 10, 20). Potremmo rievocare, a questo proposito, l'intuizione di un famoso teologo protestante: stravolgendo con una sola lettera il celebre motto cartesiano, Karl Barth aveva sintetizzato ogni nascita alla fede così: Cogitor, ergo sum, "sono pensato ("amato" secondo il linguaggio biblico), quindi sono".
Il primato della grazia divina ovviamente non elide la libertà del chiamato che può sottrarsi o allentare i tempi della conversione. Significativo è il percorso dell'altro celebre convertito della storia, Agostino. Il fascino dell'ideologia, l'attrazione del piacere, le esigenze del successo lo trattengono a lungo nella palude di un'esistenza piacevole ma insoddisfacente. Alla fine, però, la voce di Ambrogio, il convincente vescovo di Milano e l'epifania divina celata sotto una voce infantile che lo invita: Tolle, lege; tolle, lege!, lo conducono a prendere in mano e a leggere il codice dell'epistolario paolino che il futuro santo apre su un appello decisivo: "Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a gozzoviglie e ubriachezze, non fra impurità e licenze, non in contese e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri!" (Romani, 13, 13-14).
Era l'estate del 386: nasceva così uno dei maggiori Padri della Chiesa, sbocciava quel capolavoro che saranno le Confessioni, storia di una conversione, si apriva l'itinerario ideale di uno dei geni dell'umanità e si delineava anche il modello di ogni conversione, talmente intrecciata con la scelta ascetica del vescovo di Ippona da aver successivamente fatto designare i monaci nella loro professione di vita religiosa come conversi. Certo, tanti altri sono i convertiti emblematici, a partire dalla peccatrice evangelica o da Zaccheo, passando per Francesco d'Assisi o Ignazio di Loyola, fino al nostro Manzoni.
Tante saranno le conversioni più modeste e nascoste che coinvolgeranno pure i transiti da una fede all'altra. Ma per tutti risuonerà sempre quel monito di Cristo: "Convertitevi!", destinato anche a chi frequenta i luoghi di culto e si ritiene un credente che non ha bisogno di conversione. Due importanti teologi francesi del Novecento, Jean Daniélou e Yves Congar, per vie diverse giungevano, infatti, alla stessa conclusione: "Un cristiano non è che un pagano sulla via della conversione (...) Le nostre chiese sono ancora piene di pagani che vanno a messa".
Per la tradizione cristiana il prototipo per eccellenza del convertito rimane, comunque, la figura di Paolo. Egli rievoca, autobiograficamente, in modo allusivo nelle sue lettere l'esperienza vissuta - forse nell'anno 32 - sulla strada che lo stava conducendo a Damasco.
Così, scrivendo ai cristiani di Filippi, ricorre a un folgorante verbo greco, katelèmften, cioè "fui afferrato, ghermito, conquistato, impugnato" da Cristo (3, 12). In altri passi del suo epistolario si accontenta di indicare una divisione netta tra un "prima" e un "poi", linea di demarcazione tra il persecutore e l'apostolo di Cristo (Galati, 1, 11-17; Filippesi, 3, 3-17; 1 Timoteo, 1, 12-16): non per nulla nel suo famoso oratorio Paulus il musicista Felix Mendelssohn-Bartholdy farà impersonare da due bassi diversi la voce di Paolo prima e dopo la conversione.
Ai Corinzi semplicemente chiede con una domanda retorica: "Non ho io visto Gesù, il Signore?" (i, 9, 1) e conferma: "Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto" (i, 15, 8). Oppure, riferendosi a un simbolo luminoso (che poi riprenderemo), ricorda che "Dio rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria divina che brilla sul volto di Cristo" (ii, 4, 6). Il massimo che riusciamo a strappargli è ciò che confessa ai Galati: "Quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché lo annunziassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi tornai a Damasco" (1, 15-17).
Se vogliamo sapere qualcosa di più di ciò che accadde su quella strada per la capitale siriana (diventata l'emblema delle conversioni: si pensi solo all'opera Verso Damasco del drammaturgo svedese August Strindberg), dobbiamo ricorrere a chi - almeno per un certo periodo della sua vita - fu compagno dell'Apostolo nei suoi viaggi missionari, cioè san Luca.
Ebbene, egli nella sua seconda opera, gli Atti degli apostoli, per ben tre volte narra la svolta radicale che fece di Paolo un missionario di quella "setta" che egli voleva contrastare con fierezza fin nel territorio della Siria. Infatti, Luca ricorda che egli recava con sé "lettere" del sommo sacerdote gerosolimitano destinate alle comunità ebraiche damascene perché si impegnassero nel bloccare la nuova eresia che veniva denominata (a più riprese negli Atti) col suggestivo vocabolo "Via".
La prima narrazione è nel capitolo 9 ed è alla terza persona. Due sono gli atti. Da un lato, c'è l'incontro di Paolo con Gesù e poi con un membro della comunità cristiana di Damasco di nome Anania, che non solo gli va incontro accogliendolo come un fratello, ma che lo libera anche dalla cecità causata dal bagliore della visione. D'altro lato, c'è ormai l'Apostolo che "subito nelle sinagoghe annuncia che Gesù è il Figlio di Dio" (v. 20). Ma fermiamoci per un momento all'esperienza iniziale dell'incontro, che Luca dipinge coi contorni di una visione, simile a quelle che costellano la Bibbia e che hanno come destinatari, ad esempio, il patriarca Giacobbe o i profeti Ezechiele e Daniele. Ecco le parole dell'evangelista: "All'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Rispose: Chi sei, o Signore? E la voce: Io sono Gesù, che tu perseguiti!" (9, 3-5).
Come è evidente, non si parla di una caduta da cavallo come amerà immaginare l'iconografia successiva (chi non ricorda il celebre dipinto di Caravaggio in Santa Maria del Popolo a Roma?), ma di una folgorazione che fa incespicare e cadere a terra. C'è un elemento interessante in quel dialogo tra Saulo (che è il nome ebraico dell'Apostolo e che vuole idealmente marcare il suo passato, destinato ora a morire con "l'uomo vecchio", per usare una nota espressione paolina) e la voce di Cristo. Saulo stava recandosi a Damasco per incatenare i discepoli di Gesù; Cristo si identifica con loro: "Io sono Gesù, che tu perseguiti!".
Come ha fatto notare Benedetto xvi nel suo discorso di apertura dell'anno paolino, Cristo stabilisce un nesso di identità con la Chiesa che è il suo corpo. Ed è altrettanto significativa una nota apparentemente marginale ma forse allusiva: Saulo rimane cieco per tre giorni (9, 9) e quando viene battezzato si dice che i suoi occhi si illuminano ed egli "si alza": ora il verbo greco anàstas, l'"alzarsi", è lo stesso che viene usato nel Nuovo Testamento per la risurrezione di Cristo. Ai tre giorni oscuri del sepolcro subentra il levarsi luminoso della risurrezione-rinascita: nella Lettera ai Romani Paolo descriverà il battesimo in modo analogo, secondo lo schema della "sepoltura-risurrezione" di Cristo (6, 3-9).
Abbiamo detto che sono tre i racconti lucani di questa avventura spirituale radicale vissuta dall'Apostolo. Riserviamo un cenno anche agli altri due. Nel capitolo 22 degli Atti, la narrazione è in prima persona. Siamo nel tempio di Gerusalemme e Paolo sta per essere linciato dai suoi antichi correligionari. Ma il comandante della coorte romana di stanza in quell'area lo sottrae alla folla e lo conduce nella fortezza Antonia, ove gli concede di arringare il popolo che continua a pressarlo. In ebraico Paolo racconta autobiograficamente la vicenda della via di Damasco, ricalcando il primo testo degli Atti. Egli, però, sottolinea ora che i suoi compagni di viaggio "videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava", a differenza del primo racconto ("sentivano la voce, ma non vedevano nessuno" 9, 7). Si tratta, quindi, di un'esperienza che ha qualche eco esterna, ma che rimane profondamente personale e interiore. Ci sono stati, perciò, alcuni critici che hanno parlato in modo "razionalistico" di allucinazione.
In realtà, la menzione esplicita dei personaggi coinvolti (anche con nomi propri, come Giuda che ospita Paolo a Damasco nella sua casa sulla "via Diritta" o come il citato Anania) attesta il realismo di un evento che è confermato, come si diceva, anche da una terza testimonianza. Essa è presente in Atti 26, 12-23. Ora l'Apostolo è agli arresti presso il governatore romano Festo nella città di Cesarea Marittima, la residenza degli alti funzionari imperiali in Palestina (si ricordi che qui si svolgerà anche la vicenda del centurione Cornelio, descritta nel capitolo 10).
In visita ufficiale in quella città costiera si presenta la coppia principesca di Agrippa ii, discendente del re Erode, e di sua sorella Berenice che era anche la sua compagna incestuosa. Ebbene, Paolo davanti a loro - in attesa di essere trasferito a Roma per il processo d'appello da lui richiesto come cittadino romano - ripete la storia della sua conversione al cristianesimo.
La sostanza dell'evento è sempre la stessa, ma appaiono anche alcune variazioni e novità. Così, non entra in scena Anania; a terra cadono pure i compagni di viaggio e non solo Paolo; curiosamente Cristo cita un proverbio greco, attestato anche dagli scrittori Euripide e Pindaro, che è però detto dalla voce divina in ebraico: "Duro è per te recalcitrare contro il pungolo" (26, 14). L'immagine è forte e vivace ed è desunta dal mondo agricolo: il contadino stimola l'animale da soma con un bastone chiodato in punta.
Ma le parole di Cristo, in questo racconto, vanno oltre e delineano la futura missione dell'Apostolo, "ministro e testimone", quella di "aprire gli occhi (a ebrei e pagani, proprio come era accaduto allo stesso Paolo) perché passino dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio e ottengano la remissione dei peccati e l'eredità" della salvezza (26, 18). Sono queste le ultime parole di Cristo presenti nell'intera opera lucana, un mirabile suggello alla storia di un convertito, che per tutta la sua vita e con tutta la sua stessa esistenza testimonierà quelle parole di Gesù da noi citate in apertura alla nostra riflessione: "Convertitevi e credete!".
(©L'Osservatore Romano - 3 agosto 2008) __________________________________________________
 |
| |
| | | OFFLINE | Post: 11.290 | Registrato il: 03/10/2008
Registrato il: 01/11/2008 | Sesso: Maschile | |
|
Storie di conversione: Giuseppe Ungaretti
«E Tu non saresti
che un sogno?» di Claudio Toscani
"Chiuso fra cose mortali / (Anche il cielo stellato finirà) / Perché bramo Dio?". È il primo lampo religioso di Giuseppe Ungaretti, reperibile in Dannazione del 29 giugno 1916, cui segue, stessa data, Risvegli, dall'annientante: Ma Dio cos'è?
Uno sguardo alle Concordanze - edite nel 1993 dall'editore Olschki - fornisce rivelanti ricorrenze ai lemmi "Cristo", "Dio" e "Signore", ma se teniamo da subito presente la data della settimana santa del 1928 - momento della conversione - relativamente poche sono le frequenze dei sacri nomi precedenti l'evento.
 Giusto del 1828 è La Pietà, poesia nella quale, mentre si dichiara ferito, inquieto, malinconico, debole fra uomini deboli ("fiumana d'ombre"), chiede: "Dio, coloro che t'implorano / Non ti conoscono più che di nome?", e poco dopo: "E tu non saresti che un sogno, Dio?". Pure del 1928 è La preghiera, ma qui il Signore è un "sogno fermo", un rasserenante patto tra Lui e gli uomini. Giusto del 1828 è La Pietà, poesia nella quale, mentre si dichiara ferito, inquieto, malinconico, debole fra uomini deboli ("fiumana d'ombre"), chiede: "Dio, coloro che t'implorano / Non ti conoscono più che di nome?", e poco dopo: "E tu non saresti che un sogno, Dio?". Pure del 1928 è La preghiera, ma qui il Signore è un "sogno fermo", un rasserenante patto tra Lui e gli uomini.
Nato ad Alessandria d'Egitto l'8 febbraio del 1888 da famiglia italiana proveniente dalla Lucchesia, gente rigorosamente religiosa, madre pia e tollerante, Ungaretti lascia ventiquattrenne la città natale per Parigi. Conosce l'Italia ma non vi approda che nel 1914, a Milano, da dove si trasferisce poi a Roma, nel 1921, dopo aver pubblicato Il porto sepolto (1916) e Allegria di Naufragi (1919).
Biografia e bibliografia di Ungaretti sono talmente note, e il tema di queste righe talmente pregnante, che non c'è spazio per ripercorrere vita od opere se non in rapporto al motivo assunto (per comodità si ricorda che Sentimento del tempo esce nel 1933, Il dolore nel 1947 e La terra promessa nel 1950).
Della religione che vede praticata in Egitto, il giovane Ungaretti è colpito dai precetti che aderiscono alla sensualità, a cominciare dalla condivisione, da parte dei fedeli arabi, di ogni atto della propria vita, anche fisica, con la divinità, ma al momento della rivelazione cristiana quella dimensione trasmuterà in lui in un discorso di ricca e piena e viva verità umana dentro un ben altro discorso d'amore. Poi, per lui la religione sarà più propriamente speranza, se pur di fronte al mistero, e la poesia, da quando diventerà la fondante forma della sua espressione, atto di liberazione secondo una nozione di libertà che è nozione stessa di Dio: "Il sentimento della libertà è poesia, slancio di comunione con il divino, con Iddio il quale è libertà intatta, onnipotenza pura".
Semplice a volte e a volte impossibile risalire alle origini d'una sia pur dichiarata e datata svolta religiosa: in Ungaretti se ne colgono tracce dagli esordi nonché un definitivo sigillo nell'inoltrata vecchiaia: stratigrafia dell'anima che alla fine ci consegna in un altalenante, ma assiduo seguito di accensioni, transiti, lieviti, tensioni e fermenti. Non si assesta d'un tratto, in lui il credente, anche se la dichiarazione è inoppugnabile e circostanziata.
"Nel 1928, dal Monastero di Subiaco dove avevo trascorso ospite una settimana, di ritorno da Marino dove allora risiedevo, d'improvviso - in quell'anno mi sarebbero nati gl'Inni - seppi che la parola dell'anno liturgico mi si era fatta vicina all'anima. Non che, nella sua attuale perennità, quella parola non mi trovasse a volerla amare, da lunghi anni intento. Nella parola mi ero affannato sino dai miei inizi...".
L'eterno, la verità, la pietà, l'innocenza: non c'è un solo istante in cui la poesia di Ungaretti non muova da un'aspirazione in qualche modo religiosa, ma da quel momento in poi si fa più scavato e fisso il rapporto con le leggi inconoscibili della storia, del millenario operare dell'uomo via via più schiavo di un transito terreno complesso e stritolante.
"Una civiltà minacciata di morte mi induceva a meditare il destino dell'uomo e a sentire il tempo, l'effimero, in relazione con l'eterno. La mia poesia stava per non accorgersi più di paesaggi e accorgersi invece con estrema inquietudine, perplessità, angoscia, spavento, della sorte dell'uomo".
Egli stesso è diviso, anche se dentro di sé ha deciso, tra appagamento e interrogazione, preghiera e angoscia, felicità e spavento, deserto e "terra promessa". Canzone e grido.
A suo tempo, ogni cosa: molto di tutto ciò già verificato, molto da vivere da qui in avanti e sino alla fine. Il buio che dentro di sé cerca di diradare, si infittisce nel mondo; tra gli uomini e la verità la frattura si fa abissale; il pensiero umano naufraga in un suo fondo inferno materialista.
Da quando Ungaretti si fa esplicitamente cattolico, le antiche sinopie religiose della sua poesia si animano di una inedita fede in cose supreme, quelle stesse che Mario Apollonio aveva accreditato da tempo ai versi del poeta e del compagno di strada, lingua del vivere e dell'essere.
Ungaretti si era recato a Subiaco in vicinanza della Pasqua del 1928 ospitato dall'amico don Francesco Vignanelli - anche lui prima incredulo, nonostante avesse un fratello monaco nell'abbazia di Montecassino, poi convertitosi e frate benedettino. Non era la prima volta che si recava alla grotta del "Sacro Speco" della cittadina laziale: nel 1925 vi era giunto con la moglie Jeanne Dupoix (morta nel 1958), ma ora arrivava in treno, in profonda crisi religiosa, per la liturgia pasquale e per partecipare agli esercizi spirituali.
"M'hai discacciato dalla vita. // Mi discaccerai dalla morte?". È un altro distico de "La pietà". E poi: "Fulmina le mie povere emozioni, / Liberami dall'inquietudine. // Sono stanco di urlare senza voce".
Sarà l'asciuttezza, la secchezza della pronuncia, la sua sconvolgente intensità sempre abitata dall'anima, ma ogni parola sembra rimandare a un assoluto.
Questa la prima risoluta manifestazione d'una "consegna" a Cristo; questa la fine della lunga e a volte inconscia aspettazione di una fede che: "Anche se altre mire prima mi seducevano, nella mia persona dissimulandosi non cessava d'attendere".
Cos'altro opporre alle parole di una lettera di poco prima a Jean Paulhan - Je ne vais pas me convertir, mais essayer de trouver un peu de repos. Je suis très profondement païen, et tout de même j'ai l'âme chrétienne - se non la speranza del Nome dentro l'orrore del vuoto?; l'ansia del sacro, o d'un registro "alto", dentro il dubitoso perdurare di un'assenza ontologica?; una religiosità già scavata e sgomenta di fronte all'ultima protesta dello scetticismo?
Ma se di ogni conversione è giusto, interessante, doveroso, conoscere sintomi e segnali, non meno giustificato, attraente, necessario, verificarne la tenuta e la coerenza nel passare del tempo.
Per Ungaretti, una sorta di metafisica prova del nove, o di giobbico assalto al baluardo del suo credo, avviene un decennio dopo il fatidico, o meglio il provvidenziale 1928: il figlio Antonietto ha nove anni quando, per una diagnosi errata, muore di peritonite a metà del 1939. E sarà il tempo di un improgettato, imprevedibile dolore che esigerà quasi altri dieci anni per vedere la luce come omonima raccolta.
Nella vita, nella memoria, nell'anima, riappare il dramma manzoniano espresso nell'inossidabile Natale del 1833. Strazio, tormento, sbigottimento, grido: una consonanza che lo terrà, in così assediato fortilizio della fede, ancorché colpito e travolto, saldo e salvato ("Ora che osano dire / le mie blasfeme labbra: / "Cristo, pensoso palpito, / Perché la Tua bontà / S'è tanto allontanata?"").
Ma è però vero, e in ciò sta il segno della autenticamente cristiana redenzione del suo dolore, che l' interrogativo posto da Ungaretti non è a scudo esclusivo del suo dramma. Stando tempi di bellica tragedia europea, il poeta conclude: "Cristo, pensoso palpito, / Astro incarnato nell'umane tenebre, / Fratello che t'immoli / Perennemente per riedificare / Umanamente l'uomo, / Santo, santo che soffri, / Maestro e fratello e Dio che ci sai deboli, / Santo, santo che soffri / Per liberare dalla morte i morti / E sorreggere noi infelici vivi, / D'un pianto solo mio non piango più".
Corrispondenza cercata e raggiunta, nell'infinito Dio di tutto e tutti, del dolore singolo e universale. Non sarà ancora la catarsi assoluta, ma è certo il momento pieno ed esaltante nella fede in una provvidenza che agisce nella storia.
Il dono della conversione continua a mettere anima nelle parole.
La rivelazione in lumine crucis ha definitivamente liberato l'uomo e il poeta dal suo pianto solitario e disperato.
(©L'Osservatore Romano - 7 agosto 2008) __________________________________________________
 |
| |
| | | OFFLINE | Post: 11.290 | Registrato il: 03/10/2008
Registrato il: 01/11/2008 | Sesso: Maschile | |
|
Storie di conversione: Angela Pak, dalla Corea in Italia con una Bibbia in mano
Cammina adagio nella corsa della vita di Giulia Galeotti
Alla fine degli anni Trenta, una bimba di appena quattro anni corre rapida per le strade di Sinuiju, un centro al confine settentrionale della Corea, che in quegli anni è ancora tutta sotto la dominazione giapponese. È Angela Pak, primogenita di una famiglia giunta da poco nella cittadina. Non conoscendo nessuno, la madre - che ha un'altra bimba di due anni e aspetta il terzo figlio - la manda a fare la spesa. Nonostante gli inviti, i rimproveri e gli ammonimenti, portando il cibo a casa, la bambina corre, corre sempre. "Non correre - le dice la madre - rischi di farti male". Ma Angela non smette, è sicura: "non cadrò". "Non correre - le dice ancora la madre - vedendoti andare così velocemente con la spesa in mano, la gente crederà che hai rubato". Ascoltando queste parole, Angela si ferma un attimo: per la prima volta, a soli 4 anni, la bimba sente chiaramente risuonare in lei la voce della coscienza. "Io so di non aver rubato, io so di essermi comportata con rettitudine: cosa mi interessa di ciò che gli altri possono credere?".
Da allora e per tutta la sua vita, sempre correndo, Angela ha continuato a seguire quella voce. La voce che cerca la Verità. La voce che, in questa ricerca, le ha fatto conoscere la Chiesa cattolica, e l'ha condotta fino all'udienza privata da Giovanni xxiii. È il 1961: ascoltata la sua storia, il Pontefice pronuncia due parole: "Cammina adagio".
Trascorrono oltre vent'anni tra i due episodi. Da quelle prime corse all'ammonimento del Papa, si sono avuti grandi cambiamenti nel mondo, in Corea, nella Chiesa e nella vita di quella bimba, ormai diventata adulta. Attraverso nuovi incontri e nuove scoperte, tra enormi gioie e grandi dolori, Angela è sbocciata nella donna dallo sguardo appassionato che ci siede accanto raccontandoci della sua vita, e di una fede che lentamente rompe gli argini e trasforma ("la vita cristiana è vivere Cristo risorto"). Oltre che la forza del Signore - ci viene da aggiungere - questa donna minuta testimonia anche il coraggio di lasciarsi trasformare dalla fede.
 Tornando agli anni Cinquanta, gli eventi internazionali sconvolgono la vita di Angela e della sua numerosa famiglia (i fratelli sono ormai cinque). Qualche anno dopo l'indipendenza (1943), la Corea è divisa in due: il 15 agosto 1948 viene proclamata la Repubblica di Corea nel Sud sotto l'influenza americana, mentre il 9 settembre nasce la Repubblica Democratica Popolare di Corea nell'orbita sovietica. Angela si trova così a crescere in un Paese in cui non si può né pensare né parlare. Per l'adolescente curiosa, profonda e riflessiva che è diventata, la situazione è fonte di enorme sofferenza. Nel tempo, infatti, la voce della Verità ha continuato ad accompagnarla, mentre la rettitudine dei suoi genitori è per lei una guida e uno stimolo costante: la famiglia, che non conosce il cristianesimo, vive animata da saldi principi. Il gesto di sua madre, che è buddista e prega regolarmente per il bene dei figli, sempre pronta ad aprire la porta e a spartire il riso con i monaci che passano lungo la via, rimane indelebilmente impresso nella mente della figlia maggiore. Tornando agli anni Cinquanta, gli eventi internazionali sconvolgono la vita di Angela e della sua numerosa famiglia (i fratelli sono ormai cinque). Qualche anno dopo l'indipendenza (1943), la Corea è divisa in due: il 15 agosto 1948 viene proclamata la Repubblica di Corea nel Sud sotto l'influenza americana, mentre il 9 settembre nasce la Repubblica Democratica Popolare di Corea nell'orbita sovietica. Angela si trova così a crescere in un Paese in cui non si può né pensare né parlare. Per l'adolescente curiosa, profonda e riflessiva che è diventata, la situazione è fonte di enorme sofferenza. Nel tempo, infatti, la voce della Verità ha continuato ad accompagnarla, mentre la rettitudine dei suoi genitori è per lei una guida e uno stimolo costante: la famiglia, che non conosce il cristianesimo, vive animata da saldi principi. Il gesto di sua madre, che è buddista e prega regolarmente per il bene dei figli, sempre pronta ad aprire la porta e a spartire il riso con i monaci che passano lungo la via, rimane indelebilmente impresso nella mente della figlia maggiore.
Intanto, tra le due Coree scoppia il conflitto che durerà tre anni (1950-1953). La guerra vive fasi alterne. A un certo punto, quando sembra che il Sud stia per avere la meglio, la Cina scende in aiuto dei comunisti. Sebbene abbia solo 16 anni, Angela comprende perfettamente due cose: bisogna fuggire, ed è arrivato il momento opportuno per farlo, approfittando della ritirata dell'esercito sudista. Sotto il 38 parallelo vive un lontano zio, e Angela è ferma nel volerlo raggiungere. Inizialmente i genitori sono contrari: non è facile prendere la decisione di abbandonare la propria terra con tanti figli piccoli. Ma è anche difficile non ascoltare le parole di Angela, questa ragazzina così decisa, intelligente e saggia che, infatti, riesce a convincerli.
Il viaggio rocambolesco attraverso il Paese dilaniato e insanguinato segna così il traghettamento verso una nuova fase della vita.
Al Sud, Angela studia e lavora. Fa amicizia con una missionaria metodista americana che l'aiuta a realizzare il suo desiderio di imparare l'inglese. Il metodo scelto dalla sua nuova amica è profetico: Angela lo apprende attraverso la Bibbia metodista che la donna le regala. Nonostante la curiosità e l'affetto che prova per l'amica - che, ogni tanto, la porta anche in chiesa - la ragazza, pur facendo tesoro di ciò che ascolta, non è attratta da quel messaggio.
Angela, intanto, fa un altro incontro decisivo. A Seoul conosce l'ambasciatore italiano, Giorgio Spalazzi, che un giorno - si frequentano per lavoro - arriva con una notizia grandiosa: il Governo italiano ha stanziato due borse di studio per mandare due giovani coreani a studiare nella Penisola. Angela quasi non ci crede: per lei - che è sempre stata attratta dall'Europa (non dagli Stati Uniti, meta invece di molti sudcoreani) - è un'occasione d'oro. Appresi i primi rudimenti di italiano, vinta la borsa, continua a fare esercizio sulla nave che, salpata da Hong Kong, la porta a Napoli. La destinazione finale è Roma.
Angela ha 24 anni quando arriva in Italia. È il 20 ottobre 1959. Non c'è molto tempo per ambientarsi: il 15 novembre iniziano le lezioni alla Sapienza. Proprio alla facoltà di Lettere, Angela conoscerà "uno dei due sacerdoti che hanno segnato la mia vita". Si tratta di padre Ilarino da Milano - predicatore apostolico di Papa Giovanni - che insegna Storia del cristianesimo. Ascoltando e conoscendo il professore, Angela capisce che è la Chiesa cattolica ciò che lei cerca. La Verità parrebbe averla condotta qui.
A questo punto, però, il racconto di Angela ci chiama tutti in causa come fedeli, nel nostro dovere di testimoniare con gesti e comportamenti, piuttosto che attraverso parole o grandi proclami. Angela, che vive all'epoca in un istituto religioso di suore laiche, comunica entusiasta la decisione di ricevere il battesimo. "Brava, ottima decisione - le viene detto - così andrai in Paradiso". Questa frase ha su di lei l'effetto di una frustata. È un commento che proprio le non piace e che rifiuta con decisione. "Che ne sarà, infatti - si chiede - dei miei genitori e dei miei familiari che, pur non battezzati, vivono con coscienza e profonda onestà? Dove andranno loro, una volta morti? Se è solo la forma che conta per questo Dio, allora forse non è questo il Dio che sto cercando. Allora, non mi battezzo. Continuerò a seguire Gesù, conosciuto e amato attraverso la lettura del Vangelo".
Se dunque la voce della coscienza ha condotto questa giovane donna sino alle soglie del cattolicesimo, sono le parole e i comportamenti della comunità ad allontanarla, facendole dubitare che Dio la voglia realmente lì. Angela infatti - ed è un tratto distintivo della sua vita - guarda alla sostanza delle cose, ne cerca l'essenza più intima e profonda. Ascoltata la decisione, padre Ilarino da Milano, pur probabilmente soffrendo nel suo cuore, non dice nulla. Il momento per Angela non è ancora giunto.
Intanto a Roma la giovane donna conosce la presidentessa dell'associazione Italia-Corea, Antonietta Satta-Medici: è l'avvio di una profonda amicizia, anche nella fede (la Satta-Medici sarà poi la sua madrina). Il tanto sofferto battesimo è, infatti, solo ritardato. L'episodio decisivo avviene durante un viaggio a Siena nell'agosto del 1960, quando, girovagando per la città, Angela entra per caso in una piccola chiesa, dove si sta celebrando la messa. È il momento della comunione. Improvvisamente, ella sente un vento che la spinge verso l'altare: "È lui che cerchi", le dice la voce. Ancora una volta, l'anelito alla Verità ha la meglio sulle opinioni del mondo: "Non mi interessa cosa dicono gli altri, voglio seguire te". Come quella bimba di quattro anni, è questa la risposta che l'adulta Angela dà alla voce della coscienza. Voce che ormai, chiaramente, è quella di Dio.
E così, nella nuova chiesa di via Tagliamento a Roma, la mattina del 25 marzo 1961 Angela riceve il battesimo e la comunione, mentre nel pomeriggio il cardinale Cento (giunto per l'inaugurazione) le impartisce la cresima. Padre Ilarino da Milano è presente, ma non si fa vedere. Angela lo saprà solo in seguito. La data del 25 marzo ritorna più volte nella storia della sua famiglia: in quattro hanno ricevuto il battesimo proprio il 25 marzo (l'ultima, quarant'anni dopo quel lontano 1961, sarà Agnese, una pronipote che vive a Tokio).
Per Angela, comincia una fase di gioia profonda. Una gioia che va condivisa con le persone care: ella scrive lunghe lettere alla sua famiglia in Corea in cui racconta e descrive la felicità e la benedizione di essere nella Chiesa. Pur nella grande distanza, le sue parole producono un'eco profonda: semi vitali che nel 1962 portano alla conversione della prima sorella e poi, anno dopo anno, di tutta la famiglia. Solo il padre morirà senza aver ricevuto il battesimo, pur avendone più volte manifestato il desiderio. In punto di morte, però, gli cade una lacrima: è quello che la Chiesa definisce il battesimo di desiderio.
Ed è la sua fede, forte seppur in costante cammino, che aiuta Angela a vivere il momento più duro della sua vita, ma anche quello più intenso, quello del maggior abbandono e della totale fiducia nel Signore, e nel suo amore: il 12 agosto 1986 muore Cristina Chiara, detta Chicchi ("Cristina Chiara era un nome troppo lungo per una bimba appena nata!"), l'unica amatissima figlia - nata dal matrimonio con un italiano, compagno di studi - che su questa terra non arriva a compiere 17 anni. Animata a sua volta da un cristianesimo maturo e fecondo, Chicchi sa bene che solo con l'aiuto di Dio avrà la forza per affrontare e sostenere la sua prova, custodendosi "fedele alla sua vocazione cristiana". Questa forza Chicchi la desidera anche per le persone che ama maggiormente ("Avrai abbastanza coraggio da affrontare l'avvenimento?", chiede ad Angela). Durante la malattia, del resto, è proprio Chicchi che la incoraggia e, per certi versi, la guida.
Così, se quando ella chiude gli occhi sua madre tocca "il fondo del dolore", ecco però che, nel sentire che l'anima della figlia si sta avvicinando al cielo, Angela si sente pervasa da una serenità profonda: il Signore vince la morte proprio nel momento in cui essa sembra strappare per sempre da noi le persone amate. Tempo dopo, leggendo le parole del salmo 117, ella comprenderà: l'amore di Dio ha prevalso sull'amore di madre. "E compresi anche - racconta dolcemente - il volto di Maria nella pietà di Michelangelo". Sostenuta passo dopo passo da Chicchi, Angela continua a comunicare la gioia della fede, in particolare facendo catechismo ai bambini della parrocchia romana di Santa Felicita ai Figli Martiri e aiutando i poveri ai Santi Apostoli.
Undici anni fa, Angela inizia a studiare l'ebraico: la sua vita entra così in una nuova fase. Da donna di profonda fede quale ella è, comprende che la parola di Dio è la cosa più importante ("Gesù dice tre volte a Satana "sta scritto", ma "sta scritto dove?" mi sono chiesta"). Avendo del resto ben chiaro che entrarvi da sola è troppo difficile, si avvia al vero incontro con la Scrittura attraverso il biblista padre Giovanni Odasso, professore di Esegesi e Teologia biblica alla Lateranense ("il secondo sacerdote che ha segnato la mia vita" racconta).
È davvero una sete profonda la sua: Angela cita le parole di Girolamo secondo cui "l'ignoranza della scrittura, è l'ignoranza di Gesù" (è stato grande lo stupore di questa incredibile donna quando ha scoperto che ogni sacerdote non è anche un biblista).
E così, forte delle parole di Isaia "se crederete, avrete la stabilità", Angela vive quotidianamente "la liturgia della parola di Dio". Ringraziando costantemente a ogni respiro il Signore, nella sua ricerca della verità, del Regno di Dio e della sua giustizia, con gli occhi raggianti Angela invita anche noi "a vivere da risorti sulla terra".
(©L'Osservatore Romano - 11-12 agosto 2008) __________________________________________________
 |
| |
| | | OFFLINE | Post: 11.290 | Registrato il: 03/10/2008
Registrato il: 01/11/2008 | Sesso: Maschile | |
|
Storie di conversione: Alessandra di Rudinì da Gabriele D'Annunzio al Carmelo
Il bisogno insopprimibile
di essere amata davvero di Lucetta Scaraffia
 Il 5 agosto 1910, tra la folla che assisteva commossa a una guarigione miracolosa nella grotta di Lourdes, vi era un'aristocratica italiana leggendaria per bellezza ed eleganza, Alessandra di Rudinì. La nobildonna si era recata a Lourdes su consiglio del precettore dei suoi figli, il francese abbé Gorel, con la speranza di trovare finalmente la fede. Da anni cercava, con tutte le sue forze, la conversione: si era ritirata a vivere nella splendida villa sul Garda che aveva ereditato dal marito morto precocemente di tisi, dedicandosi allo studio della teologia, della liturgia e delle vite dei santi, e ai colloqui con i prelati dei dintorni - e naturalmente con Gorel - che venivano sottoposti a stressanti sedute in cui erano costretti a rispondere ai suoi dubbi e alle sue critiche. Questo avvicinamento puramente intellettuale alla fede cattolica, vissuto per di più con la prepotenza di una aristocratica abituata sin dall'infanzia a ottenere quello che voleva, non poteva certo assicurarle quella pace interiore a cui tanto anelava. Il 5 agosto 1910, tra la folla che assisteva commossa a una guarigione miracolosa nella grotta di Lourdes, vi era un'aristocratica italiana leggendaria per bellezza ed eleganza, Alessandra di Rudinì. La nobildonna si era recata a Lourdes su consiglio del precettore dei suoi figli, il francese abbé Gorel, con la speranza di trovare finalmente la fede. Da anni cercava, con tutte le sue forze, la conversione: si era ritirata a vivere nella splendida villa sul Garda che aveva ereditato dal marito morto precocemente di tisi, dedicandosi allo studio della teologia, della liturgia e delle vite dei santi, e ai colloqui con i prelati dei dintorni - e naturalmente con Gorel - che venivano sottoposti a stressanti sedute in cui erano costretti a rispondere ai suoi dubbi e alle sue critiche. Questo avvicinamento puramente intellettuale alla fede cattolica, vissuto per di più con la prepotenza di una aristocratica abituata sin dall'infanzia a ottenere quello che voleva, non poteva certo assicurarle quella pace interiore a cui tanto anelava.
Apparentemente Alessandra aveva avuto tutto dalla vita: era nata in una potente e ricca famiglia siciliana - il padre Antonio, proprietario di latifondi, era stato più volte presidente del Consiglio - ed era bellissima, alta, bionda, piena di vita e di intelligenza. Ma le era mancato, sin da piccola, l'affetto dei genitori: del padre, assorbito dalla carriera politica e dalle avventure amorose, e della madre, una nobile piemontese con ascendenze russe, sofferente per questa situazione e incapace di reagire, finita presto in un ospedale psichiatrico. Lasciata alle governanti, e poi nei collegi, aveva sviluppato un carattere ribelle e insofferente, che trovava pace solo nel rapporto con gli amatissimi cani e cavalli, che soli le davano quell'affetto a cui anelava.
Assediata dalle richieste di matrimonio, scelse un nobile timido e defilato come il marchese Marcello Carlotti del Garda, perché lo aveva visto slanciarsi in soccorso di un cavallo caduto per strada. Dal matrimonio, durato solo cinque anni per la morte del marito, erano nati due figli, con i quali Alessandra ebbe un rapporto freddo e contraddittorio. Rimasta vedova a ventitré anni, si gettò nella vita mondana e nei viaggi, anche esotici, fino alla svolta centrale della sua vita: l'incontro con Gabriele D'Annunzio, che la corteggiò abilmente fino a ottenerne la resa. Nel poeta, nelle sue frasi trascinanti e nelle sue promesse di una passione totalizzante, le sembrò di trovare finalmente una risposta alla sua fame di amore. D'Annunzio, che l'aveva soprannominata Nike, le scriveva messaggi seducenti e ingannatori: "Io sarò tutto per te. Sarò per te tutto ciò che vorrai che io sia; saprò colmare i vuoti che il mio amore avrà scavato intorno a te".
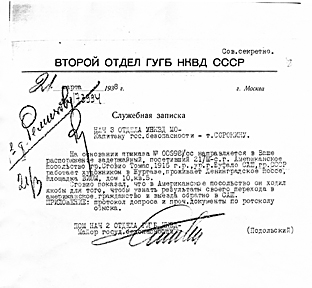 Alessandra gli crede con totale fiducia, si abbandona a questo amore accettando lo scandalo e i rimproveri del padre, che la disereda, e del cognato, che avoca a sé la custodia dei figli. Per D'Annunzio abbandona tutti e tutto, dimentica gli affetti più cari. Per qualche anno la coppia sembra vivere d'amore - e di spese pazze: Alessandra, che va a vivere con D'Annunzio alla Capponcina, pretende per i suoi cani collari ornati di gemme e tappeti preziosi - e il poeta la assiste con amorevole abnegazione durante una lunga e brutta malattia, da cui Alessandra esce distrutta anche perché si è abituata all'uso di morfina per lenire i dolori. Ma, dopo quattro anni, per il poeta è tempo di altri amori. D'Annunzio si libera con crudeltà del legame con la nobildonna, che ormai lo ha stancato. Per Alessandra la delusione è insostenibile: il vuoto affettivo che sente dentro di sé, la fame di amore, si riapre ancora più dolorosamente, e i suoi tentativi di rappacificazione sono tanto inutili quanto disperati. È in questa fase dolorosa che l'aristocratica cerca il conforto della religione, ma non riesce ad aprirsi alla fede, nonostante la desideri così intensamente. La dolcezza del pentimento di una Maddalena le è negata, e Alessandra alterna letture di teologia a messaggi disperati che invia al poeta. Alessandra gli crede con totale fiducia, si abbandona a questo amore accettando lo scandalo e i rimproveri del padre, che la disereda, e del cognato, che avoca a sé la custodia dei figli. Per D'Annunzio abbandona tutti e tutto, dimentica gli affetti più cari. Per qualche anno la coppia sembra vivere d'amore - e di spese pazze: Alessandra, che va a vivere con D'Annunzio alla Capponcina, pretende per i suoi cani collari ornati di gemme e tappeti preziosi - e il poeta la assiste con amorevole abnegazione durante una lunga e brutta malattia, da cui Alessandra esce distrutta anche perché si è abituata all'uso di morfina per lenire i dolori. Ma, dopo quattro anni, per il poeta è tempo di altri amori. D'Annunzio si libera con crudeltà del legame con la nobildonna, che ormai lo ha stancato. Per Alessandra la delusione è insostenibile: il vuoto affettivo che sente dentro di sé, la fame di amore, si riapre ancora più dolorosamente, e i suoi tentativi di rappacificazione sono tanto inutili quanto disperati. È in questa fase dolorosa che l'aristocratica cerca il conforto della religione, ma non riesce ad aprirsi alla fede, nonostante la desideri così intensamente. La dolcezza del pentimento di una Maddalena le è negata, e Alessandra alterna letture di teologia a messaggi disperati che invia al poeta.
Sarà proprio a Lourdes, nel raccoglimento della Grotta, che la nobildonna sentirà esaudita la sua preghiera, avvertendo la fede e la pace dentro di sé: nei momenti più duri della sua vita aveva promesso a Dio che, se avesse ricevuto il dono della fede, si sarebbe donata interamente a lui, entrando nel Carmelo. La sera stessa del "miracolo", Alessandra chiede all'abbé Gorel di confessarla: "Tutte le esitazioni, tutti i tentennamenti, tutte le resistenze, erano vinte, e questa volta per sempre", annota l'ecclesiastico dopo questa confessione, mentre a sua volta la penitente gli scriveva: "Prego Dio che questa speranza e questa fede nate in me come una luce nuova, possano diventare una cosa nuova e piena di vita". Al ritorno da Lourdes Alessandra affretta i tempi per entrare in convento, e sceglie il Carmelo di Paray-le-Monial, dove trova un'affettuosa e comprensiva accoglienza presso la superiora, Marie de Jésus, della quale prenderà anche il nome. Rapidamente, si abitua alla durissima vita monacale, si impegna eroicamente come infermiera nel monastero, e alla morte della fondatrice viene eletta al suo posto. Le sue cospicue sostanze - nel frattempo, aveva ereditato dai figli morti di tisi e dal fratello suicida - vennero impiegate nel completamento del convento di Paray-le-Monial, e nella costruzione di altri tre: a Parigi, accanto alla nuova basilica di Montmartre, a Valenciennes e nelle montagne della Savoia, dove Alessandra morì e ha trovato sepoltura.
Ma rimane il dubbio che la sua conversione resti incerta, come il suo animo sempre inquieto: lo suggerisce il fatto che in alcune occasioni abbandona il monastero per recarsi in incognito in Italia, dove alloggia in un albergo in compagnia di una consorella anch'essa in vestiti normali, e che vi sono tracce di una sua corrispondenza con D'Annunzio anche dopo il suo ingresso in monastero, e soprattutto lascia perplessi il suo pressoché inesistente sentimento materno. Alessandra lascia i figli ancora bambini e bisognosi di lei, e non li assiste nei difficili momenti della loro malattia né nelle lunghe agonie, mentre invece si prodiga nell'assistenza delle consorelle malate. Sappiamo che, prima di lei, ci sono stati grandi esempi di sante che hanno lasciato i figli per diventare religiose, come Jeanne de Chantal, ma nondimeno colpisce la sua scelta di abbandonare i suoi figli, orfani del padre e malati, tanto più che anche prima non aveva dimostrato molta sollecitudine nei loro confronti. Non è possibile leggere nel suo cuore, ma possiamo sperare che nella vita religiosa Alessandra abbia placato infine la sua straziante fame di amore, sentendo accanto a sé quello di Dio.
(©L'Osservatore Romano - 18-19 agosto 2008) __________________________________________________
 |
| |
| | | OFFLINE | Post: 11.290 | Registrato il: 03/10/2008
Registrato il: 01/11/2008 | Sesso: Maschile | |
|
Storie di conversione: Berdjaev
«Tu non sei mai solo, Nikolaj» di Adriano dell'Asta
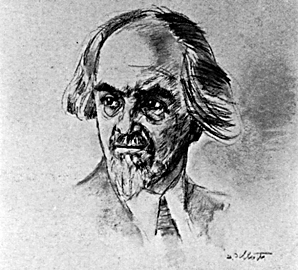 Siamo agli inizi della seconda guerra mondiale, nella casa di Nikolaj Berdjaev, vicino a Parigi. Con il grande filosofo russo, espulso dall'Unione Sovietica nel 1922 per diretto ordine di Lenin, ci sono alcuni amici; come racconta la moglie nei suoi diari, il tema della conversazione è "lo scopo e il senso degli avvenimenti. Chi si preoccupa più di ogni altro di quanto sta accadendo è il buon Mocul'skij, un altro dei grandi pensatori russi costretti ad emigrare dopo la rivoluzione. Siamo agli inizi della seconda guerra mondiale, nella casa di Nikolaj Berdjaev, vicino a Parigi. Con il grande filosofo russo, espulso dall'Unione Sovietica nel 1922 per diretto ordine di Lenin, ci sono alcuni amici; come racconta la moglie nei suoi diari, il tema della conversazione è "lo scopo e il senso degli avvenimenti. Chi si preoccupa più di ogni altro di quanto sta accadendo è il buon Mocul'skij, un altro dei grandi pensatori russi costretti ad emigrare dopo la rivoluzione.
"Nikolaj gli chiede se lavora, se scrive. "Oh, no, non riesco a scrivere neanche una riga. Solo giornali e informazioni, e niente altro!". Al che Nikolaj ribatte: "Io invece ho un'incredibile capacità di scrivere in qualsiasi condizione. Anche adesso sto scrivendo un libro, scrivo articoli, preparo conferenze. Il mio sistema nervoso è definitivamente sconvolto, o meglio, lo è la sua struttura esteriore, mentre all'interno c'è una sorta di nucleo che nulla riesce a toccare!"".
Ciò che colpisce e desta immediatamente l'attenzione nella persona di Berdjaev - a detta di chi lo ha conosciuto direttamente o ne ha studiato la vita e il pensiero - è appunto questo nucleo solido di umanità che da nulla può essere messo in crisi e che resta incrollabile, quali che siano le condizioni esteriori e a dispetto delle stesse peculiarità del suo carattere. Umanamente una persona di grande emotività e tensione nervosa; che aveva attraversato tutta la tragedia della Russia tra la fine del xix secolo e l'inizio del xx: la lotta allo zarismo, la guerra, la rivoluzione, l'emigrazione.
C'era di che essere scossi; eppure Berdjaev colpisce proprio per questa sorprendente solidità che lo rende capace di resistere anche là dove persone meno impressionabili di lui cedono alle spinte esterne. A questo proposito, nel suo Arcipelago Gulag, Aleksandr Solzenicyn, parlando della resistenza di Berdjaev nei primi anni del regime sovietico, dice: "Sono riusciti a trasformare in marionette la cerchia di Berdjaev, ma non lui medesimo. Berdjaev non si umiliò, non supplicò, ma espose con fermezza i suoi principi religiosi e morali: L'uomo aveva un punto di vista proprio!"; poteva restare solo contro tutti, ma niente gli avrebbe potuto togliere quel "punto di vista proprio", che non è il segno di chi vuol far l'originale ma di chi è libero di fronte alle circostanze, di chi non dipende da nulla che sia esterno al suo cuore.
Per quanto potesse restare solo, in realtà Berdjaev non restava mai veramente tale; come ci dice ancora la moglie: "Tu non sei mai solo Nikolaj, tu sei con Cristo".
Il mistero della solidità di Berdjaev era tutto in questa compagnia che trasformava "un'anima malata", un individualista solitario, che si era sempre sentito un estraneo in questo mondo, in un solido punto di aggregazione e di riferimento per tutti: non solo per filosofi o pensatori come lui, ma anche per gente semplice di ogni tipo, che grazie a lui ritrovava la voglia di vivere, come quel povero vecchio russo, anch'egli emigrato a Parigi - dove viveva nel totale squallore - che non poté fare a meno di regalargli una principesca azalea rosa per dimostrare in qualche modo la propria gratitudine a chi gli "aveva restituito la fede".
Qui non si può che restare ulteriormente colpiti se si pensa che quest'uomo, ormai diventato un modello di fede, aveva avuto una storia religiosa tutt'altro che semplice.
Nato nel 1874 in una famiglia di antica nobiltà, Berdjaev era diventato ben presto marxista, perché nel marxismo credeva di poter trovare una giustificazione e una risposta alla propria ansia di libertà, delusa dal conformismo e dal formalismo della società nella quale era cresciuto e della stessa Chiesa, che a un certo punto, a lui come a molti altri, era apparsa nulla più che un "involucro esterno e infangato".
Il periodo marxista non era durato molto a lungo, anche se la sua militanza rivoluzionaria era bastata a renderlo famoso come "marxista legale" e a procurargli arresti e periodi di confino; ne era uscito grazie a un percorso umano e intellettuale che aveva alcuni punti fermi: la passione per la libertà e per la persona intesa come essere irriducibile, l'attenzione alla realtà e al suo mistero, e la coscienza che tutto ciò poteva essere percepito pienamente solo con lo sguardo di Cristo, presente nella sua Chiesa. Era quanto egli stesso avrebbe detto diversi anni dopo, quando, ricordando il proprio ritorno alla Chiesa, avrebbe così riassunto l'esigenza che lo aveva caratterizzato: "Dopo le deserte vacuità del pensiero astratto, la filosofia deve tornare sotto le volte del tempio, alla sua funzione sacra, e ritrovarvi il realismo perduto, e di nuovo ricevere la consacrazione ai misteri della vita".
Il realismo e il mistero irriducibile della vita e della persona erano esattamente quello che il marxismo non poteva rispettare e quanto Berdjaev trovò in Cristo e nella Chiesa.
In effetti, in Berdjaev, la critica al marxismo e la riscoperta del cristianesimo nascono proprio attorno alla questione della realtà poiché una delle critiche più decise di Berdjaev a Marx è appunto quella di essere venuto meno alla realtà e, come dirà più tardi, di aver trasformato, per le esigenze della rivoluzione, la stessa realtà del proletariato nell'idea di proletariato. Quella che dovrebbe essere una filosofia scientifica si rivela così una cattiva scienza e una cattiva filosofia, nella quale l'idea sostituisce la realtà e nella quale, non essendoci più spazio per nulla di oggettivo, finisce per scomparire anche la verità; ma "se non c'è Dio, se non c'è Verità che lo innalzi al di sopra del mondo, l'uomo è totalmente subordinato alla necessità. L'esistenza di Dio è la carta delle libertà dell'uomo", dice Berdjaev, saldando il problema della libertà e della verità con quello di Dio e indicando quindi l'altro grande limite del marxismo nel suo ateismo. Anzi era proprio l'ateismo che rendeva impossibile per Marx un autentico rispetto della realtà: se voleva garantirsi il proprio dominio totalmente immanente sul mondo, il marxismo era infatti costretto a negare la realtà, che per la sua natura stessa rimandava necessariamente a un creatore, a un essere infinito irriducibile a qualsiasi realtà finita.
Tutta la genialità di Berdjaev e della sua riscoperta del cristianesimo stava qui però nella sua capacità di superare, in Cristo, le vecchie contrapposizioni: tra finito e infinito, trascendenza e immanenza, materia e spirito, libertà e necessità, rivoluzione e tradizione. In Cristo infatti, per Berdjaev abbiamo il superamento della sterile dialettica che paralizza l'uomo contemporaneo, insofferente ai sistemi - anche religiosi - fatti di divieti e di mondi chiusi ma nello stesso tempo umiliato dalla pura negazione, diviso tra la soppressione totalitaria della libertà e la sua riduzione borghese a indifferenza della scelta.
Tra schiavitù e anarchia, fissità e cattivo infinito, Cristo, per Berdjaev, mostra l'esistenza di un atteggiamento diverso: l'atteggiamento del Figlio, il Dio-Uomo che si incarna, e l'atteggiamento degli uomini che in Cristo divengono amici di Dio e possono rispondere liberamente al suo amore.
 In Cristo, che assume l'umanità e si espone al rischio della libertà sino alla morte di Croce, Berdjaev vede la rivelazione e il compimento della libertà umana: "La libertà umana raggiunge la sua espressione definitiva nella libertà suprema che è libertà nella Verità". In questa Verità che crea un essere libero di negarLa, e che libera donandosi sino alla morte, Berdjaev scopre che la libertà non è il risultato di una ribellione e di una lotta, ma non è neppure una condizione beata; essa è piuttosto qualcosa di originario, che costituisce l'uomo, un dono enorme, dalla grandezza drammatica e di cui molte volte l'uomo stesso vorrebbe fare a meno. Ma finché resta tale l'uomo non può fare a meno di rispondere a questo dono, che si manifesta come un'ansia di verità, un infinito che lo costituisce e lo eccede e gli impedisce di ripiegarsi sulle proprie miserie e sulle proprie cadute: "È Dio stesso e non l'uomo che non può fare a meno della libertà umana", dice Berdjaev con una delle sue formule spesso paradossali. In Cristo, che assume l'umanità e si espone al rischio della libertà sino alla morte di Croce, Berdjaev vede la rivelazione e il compimento della libertà umana: "La libertà umana raggiunge la sua espressione definitiva nella libertà suprema che è libertà nella Verità". In questa Verità che crea un essere libero di negarLa, e che libera donandosi sino alla morte, Berdjaev scopre che la libertà non è il risultato di una ribellione e di una lotta, ma non è neppure una condizione beata; essa è piuttosto qualcosa di originario, che costituisce l'uomo, un dono enorme, dalla grandezza drammatica e di cui molte volte l'uomo stesso vorrebbe fare a meno. Ma finché resta tale l'uomo non può fare a meno di rispondere a questo dono, che si manifesta come un'ansia di verità, un infinito che lo costituisce e lo eccede e gli impedisce di ripiegarsi sulle proprie miserie e sulle proprie cadute: "È Dio stesso e non l'uomo che non può fare a meno della libertà umana", dice Berdjaev con una delle sue formule spesso paradossali.
Definito dal dono e dall'incontro con la libertà divina, per Berdjaev, l'uomo si scopre persona a immagine della Persona di Cristo, e proprio per questo si trova a essere irriducibile, incessantemente chiamato a superarsi e investito di una nuova capacità di resistenza a ogni forma di potere: segnato dall'assoluto non può più essere soggetto a nulla di relativo.
Il radicamento di questa irriducibilità e della sua vocazione nella realtà della Persona di Cristo, Verbo fatto carne, distingue la posizione di Berdjaev da altre filosofie a lui contemporanee; non si tratta di un semplice spiritualismo contrapposto alla violenza materialista: lo Spirito di cui parla non è un altro mondo confinato tra le nuvole, ma l'altro mondo che ha fatto irruzione in questo mondo, non un'idea contrapposta a un'altra idea ma qualcuno che restando definitivamente altro rispetto a questo mondo ne diventa il cuore, il movente e lo scopo.
Questa irriducibilità costantemente ribadita, d'altro canto, libera l'azione dell'uomo dalla pretesa del successo e di una realizzazione immediata, da quella pretesa di perfettismo che trasforma spesso l'agire umano in un moralismo soggettivistico e utopista e che Berdjaev definisce né più né meno che una forma di nichilismo, perché l'idea del moderno umanesimo antropocentrico, l'idea di un uomo che si costruisce tutto da solo un mondo perfetto, "l'ideale della perfezione senza grazia porta al nichilismo".
E qui c'è un altro elemento fondamentale, anche se spesso poco sottolineato, del cristianesimo di Berdjaev. Il pensatore russo è giustamente considerato il filosofo della creatività: il carattere personale dell'uomo si compie autenticamente nella misura in cui l'uomo, a immagine del Creatore, crea a sua volta in piena libertà; ma questo non significa mai in Berdjaev la pretesa di un'autonomia o di una cattiva indipendenza. Per quanto riguarda la stessa creatività umana, Berdjaev ricorda che, proprio là dove essa è più alta e più originale, "l'idea stessa di creatività è possibile solo perché c'è un Creatore e perché quest'ultimo ha compiuto un atto creatore originale grazie al quale ha cominciato a esistere qualcosa che prima non c'era".
Lo spirito del ribelle, nel Berdjaev che riscopre Cristo, si trasforma nello spirito di responsabilità; e questa responsabilità si radica ed è possibile solo nella Chiesa; a dispetto di tanti atteggiamenti polemici e di tanta insofferenza nei confronti di certe chiusure della sua Chiesa, Berdjaev ripeterà sino alla morte (1948): "Io confesso la religione dello spirito, sono un cristiano libero, non uno che ha rotto con la Chiesa, cioè non voglio essere un settario"; e questo perché, come aveva detto in uno dei suoi articoli di poco successivi al ritorno nella Chiesa, solo "la Chiesa ha conservato l'immagine del Cristo crocifisso e il mistero della comunione con Lui".
(©L'Osservatore Romano - 24 agosto 2008) __________________________________________________
 |
| |
| | | OFFLINE | Post: 11.290 | Registrato il: 03/10/2008
Registrato il: 01/11/2008 | Sesso: Maschile | |
|
Storie di conversione: il duplice ritorno di Julien Green
Nell'oscurità che avvolge
il mondo resta comunque la verità di Claudio Toscani  "Vi scrivo poche parole prima di partire, per dirvi che questa mattina ho fatto la comunione, in seguito ad una conversazione che ho avuto con padre Rzewuski". Così Julien Green scrive a Jacques e Raissa Maritain il 25 aprile del 1939. "Vi scrivo poche parole prima di partire, per dirvi che questa mattina ho fatto la comunione, in seguito ad una conversazione che ho avuto con padre Rzewuski". Così Julien Green scrive a Jacques e Raissa Maritain il 25 aprile del 1939.
Narratore, diarista, saggista e commediografo, Green nasce, ultimo di otto figli, nella Parigi "rustica, desolata e magica" del 1900 da genitori americani di sangue scozzese e irlandese, puritani e protestanti. La madre viene dalla Georgia e il padre dalla Virginia. Dall'indole d'Irlanda eredita quanto essa offre di "impulsivo, sognante, carnale e instabile"; da quella di Scozia "le crisi religiose, l'amore profondo per le Scritture, la lunga ostinazione che ha quasi sempre ragione d'una connaturata pigrizia"; dal profondo Sud americano, infine, il tratto solitario, la vivace immaginazione ricca fino all'eccesso di cupi sogni notturni e languide fantasie.
I Maritain - Jacques, filosofo, ambasciatore, animatore della resistenza spirituale francese, e Raissa, sua moglie, poetessa e collaboratrice, insieme passati al cattolicesimo nel giugno del 1906 - sono amici di Green, suoi estimatori, e ne esaltano gli esiti narrativi, oltre che critici. Ne apprezzano l'amalgama tra realtà e invenzione, cioè la visionarietà del vero, e sono affascinati dall'insondabile profondità dei suoi personaggi e delle loro anime, sospese tra i tempi miserabili e sacri della vita: tenebre e stelle tra natura umana e trascendente destino.
A trentanove anni, dunque, Julien Green "riapproda" alla Chiesa di Roma, "complici" gli amici, quasi suoi direttori spirituali, fratelli maggiori con cui discutere, confidarsi e corrispondere a distanza, elaborare e commentare idee, sottoporre progetti. "Ho avuto l'impressione di incontrare un uomo - dice Green di Maritain - venuto da un altro mondo. Mi è sembrato che l'invisibile prendesse corpo, parlasse con una voce umana, mi osservasse con i suoi occhi azzurri dove si rifletteva il colore delle regioni che abitava".
S'è detto sopra: "Green riapproda alla Chiesa di Roma". Non è una svista, perché lui veniva da un sorprendente retroterra religioso - per altro, la sua stessa famiglia conoscerà una irresistibile sequenza di conversioni: per prima Mary, la sorella; poi il padre e la madre, a tempi lunghi, quando l'educazione del figlio futuro scrittore si sarà consolidata.
Nato protestante, in seguito al trauma della scomparsa della madre nel 1916 Julien si era già convertito al cattolicesimo, facendo addirittura presagire una sua entrata nell'ordine dei frati benedettini, proposito poi lasciato cadere.
Il sopraggiungere della prima guerra mondiale lo vede infermiere della Croce rossa americana sul fronte italiano non lontano da Treviso dove pure Ernest Hemingway stava militando, pur senza mai incontrarlo.
A guerra finita si iscrive, in Virginia, all' università di Charlottesville, già frequentata da Edgar Allan Poe, ma tre anni dopo rientra a Parigi.
"Cupo e studioso, vivevo all'Università della Virginia le ore più tristi della mia giovinezza".
È il 1924 quando abbandona la fede romana e pubblica uno sferzante pamphlet contro i cattolici francesi, che in ogni caso rimane un segnale della sua attenzione per quelle problematiche religiose che vivrà, fino alla riconversione, nel segno di un desiderante tormento. Ma anche a Credo ritrovato e ribadito, non tutto in lui sarà esente da dubbi, ripensamenti, intermezzi agnostici e lotte contro le tentazioni di sempre: incarnerà la testimonianza di un uomo, un romanziere e un intellettuale, che sperimentano assieme, in un'unica treccia esistenziale, moderni scrupoli e angosce di un mondo che non li sente più come presenti.
Il lettore non si aspetti di trovare trame cosiddette "edificanti" nella bibliografia creativa di Julien Green, ma un tipo di romanzo che non mostra di volersi sposare con l'aggettivo "cattolico", e anche situazioni cariche di una forza esplosiva che scardinano la coscienza, a cominciare da quelle che ospitano l'avventura di Adrienne Mesurat (1927), giovane donna assetata di libertà che per questo non rinuncia al delitto ma che paradossalmente è destinata a soccombere davanti alle tante barriere del mondo e della società. O come in Leviatan (1929), rappresentazione a tinte fosche, allucinate, del carcere che sono i nostri propri vizi, garanzie di distruzione morale oltre fisica. Anche Veruna (1940), sotto il cielo notturno d'una mitologia sanscrita che vigila sul compimento di tutti i destini, contempla personaggi smarriti, preda di forze oscure e vittime di inesorabili fatalità, ignote a tutti meno che a Dio; e così pure Moïra (1950), che s'incentra sulla figura di un universitario ossessionato dal fascino di una ragazza e così ineluttabilmente trascinato dalla sua passione da farsene travolgere fino all'orlo della perdizione. Mentre solo nel maturo Relitti (1985), nell'ambito di una stringente critica alla borghesia, Green anima un pavido e inetto protagonista che tuttavia trova un emblema di rivalsa salvifica proprio nel figlio a suo tempo concepito nell'odio.
Siamo insomma, a differenza degli scrittori di immediata e scoperta pedagogia morale e religiosa, immersi in un mondo che ha scelto l'abbandono della grazia divina. Ma cosa rimedia all'evidente squallore di queste vite se non la constatazione dell'inferno che esse stesse si procurano con la loro condotta?
Ma torniamo agli anni verdi del giovane Green: sedicenne, aveva letto l'Apologia pro vita sua del cardinal John Henry Newman - che, da parroco anglicano, si era poi convertito al cattolicesimo, ottobre 1845, salendo sino alla porpora. Chiudendo l'Apologia, che insieme al citato trauma per la morte della madre, lo stava trascinando all'ortodossia cristiana, s'era messo a fantasticare su cosa avrebbe potuto essere un libro in cui si sarebbe detto tutto, il bene come il male, per una fervida esigenza di descrivere la verità nella sua interezza, senza attenuanti né ritocchi né alcun altro tipo di accomodamento o frode. Questo sogno doloroso lo accompagnerà lungo tutta la sua vita di scrittore, nella convinzione che la verità, perfino quella più umiliante o vergognosa, ha una sua nobiltà, una sua grandezza muta che impone rispetto, dato che verità è e verità rimane.
Scriverà in un trattatello di parecchi anni dopo: "La verità è la libertà dell'anima" e, "se hai la pretesa di non deviare dalla verità, sei per forza costretto a presentare onestamente quello che chiami il male".
Una dichiarazione di poetica e la chiave stessa a quella totale e scottante, e perciò stesso seducente disinvoltura narrativa in dote ai suoi romanzi, indelebile marchio del suo essere cattolico e scrittore, estremo ma non ultimo rappresentante di una pattuglia di narratori che da Francis Jammes a Charles Péguy, da Paul Claudel a François Mauriac a Georges Bernanos, ha dimostrato la grande vitalità della cultura cattolica francese. Lui, Julien Green, che rimarrà comunque vicino ai "laici" come Proust e Gide, Baudelaire e Dostoevskij, per il comune attacco al naturalismo, padrone del proprio mondo, luce mai priva di ombre, gioia e supplizio delle proprie pagine.
"Com'è piacevole lavorare con un uomo intelligente! - scrive Green dando voce al diavolo che lo sta blandendo - Faremo qualcosa di superbo, insieme, e la morale sarà salva". "La morale?" - ribatte Green. "Certo, la morale. Faremo passare le scene scabrose sotto la bandiera della fede. Penso a tutto io". Riprende Green: "Ma quello che mi proponi è una vergogna! Io lo denuncio, il male, gli sono contro!". "Sicuro - chiude il diavolo - ma il lettore di oggi è convinto che il male non esista e che io, il diavolo, sia solo una finzione".
Green non vuol ridere di cose serie, è nel solco del suo particolare, intimo problema: e ora che ha riscoperto l' incontaminata purezza della dottrina di Cristo gli si ripresentano il mondo e la trappola del peccato, la volgarità e la violenza che abitano la storia, e persino il suo scrittoio come rischio di oggetto orrendo. Ma non volendo dire o pensare nulla lontano dalla verità - "Non si può che credere senza comprendere tutto" - accetterà l'azzardo di raccontare il degrado fisico e morale, il crimine e la morte interiore, la sconcertante e impervia vita della gente e i più terrificanti rovelli di coscienza, con l'inchiostro della fiducia, anzi, della speranza. Con l'augurio, qualcosa più che uno scialbo bagliore, magari il raggio di un'utopia, che dalla realtà del tutto emerga anche quella del diavolo, e non la sua sleale finzione.
Secondo Green, "Dio entra più facilmente in un'anima devastata dai sensi che in una barricata dietro le proprie virtù". E sebbene "i popoli camminino verso l'inferno", lui spera che non ci arrivino, perché "se Dio smettesse per un secondo di perdonare, la nostra terra se ne andrebbe in frantumi".
Chiunque avesse letto la trentina di volumi in capo a Julien Green, senza accompagnarla con la visione, almeno, di un qualche capitolo del suo ingente, incessante Journal (un diario di un'altra ventina di tomi, iniziato nel '28 e durato fino alla sua morte, settant'anni dopo), che grado a grado, passo dopo passo, fiancheggia intellettualmente e spiritualmente l'opera creativa, resterebbe privo di molte della ragioni che hanno chiarito la sua fede a se stessa.
Per esempio la fendente, spesso mistica esplorazione delle tenebre e del vuoto esistenziale che lui percepiva nel mondo come dolorosa ansia di Assoluto. O l'adesione a quella cristiana dualità di spirito e carne, male e bene, peccato e grazia che era in lui, a un tempo, coscienza del Maligno e ansia metafisica, senso del peccato e nostalgia di Dio, redenzione nell'umiltà piuttosto che disperazione nell'orgoglio.
Senza tensione, senza conflitto, non c'è per lui nemmeno pentimento, remissione, abbandono. Conservare Dio senza perdere il mondo non è possibile. Ma non è agevole. Lui è tornato alla Chiesa, e per ben due volte, perché solo in quel Grembo avrebbero avuto senso le sue sofferenze e i suoi limiti.
"Dio è violento. Spezza il cuore", gli disse un giorno un amico. "Nel '16 e nel '39 ha spezzato il mio - rispose Green - per entrarci".
Destino alto e totale, il suo: che gli prese la vita in scontri, coinvolgimenti, assestamenti, tregue, cadute e ricadute. Senza mai placargli "la fame da lupo di Dio".
Destino di uomo che vede l'immensa oscurità che ci avvolge, cose e creature tutte, nelle tenebra incandescente del male. Ma che all'atto della scrittura imponeva: "Sopprimete il peccato e sopprimerete l'opera. L'importante è che non vi sia complicità.
Tra il visibile e il mistero, ma oltre il muro del mondo.
(©L'Osservatore Romano - 28 agosto 2008) __________________________________________________
 |
| |
| | | OFFLINE | Post: 11.290 | Registrato il: 03/10/2008
Registrato il: 01/11/2008 | Sesso: Maschile | |
|
Storie di conversione: Graham Greene
Non giudicate il mondo
che vi sembra abbandonato di Giulia Galeotti
 Il 13 luglio 1965 Paolo vi riceve in udienza privata lo scrittore inglese Graham Greene (1904-1991). L'incontro ha un duplice spessore: da un lato v'è l'uomo di fede, cresciuto e maturato nel proprio cammino di conversione, che viene accolto dal suo Pontefice; dall'altro, l'autore di un romanzo incappato nelle maglie del Sant'Uffizio e l'illuminato ministro di Dio che, oltre un decennio prima, aveva saputo cogliere il valore e il profondo significato dell'opera. A tu per tu nella calda estate romana, si parlò, infatti, anche de Il potere e la gloria (1940): all'inglese che gli ricordava la condanna ricevuta, sorridendo Montini rispose: "Mister Greene, certe parti del suo romanzo non possono non offendere alcuni cattolici, ma lei non dovrebbe attribuire alcuna importanza a questo". Il 13 luglio 1965 Paolo vi riceve in udienza privata lo scrittore inglese Graham Greene (1904-1991). L'incontro ha un duplice spessore: da un lato v'è l'uomo di fede, cresciuto e maturato nel proprio cammino di conversione, che viene accolto dal suo Pontefice; dall'altro, l'autore di un romanzo incappato nelle maglie del Sant'Uffizio e l'illuminato ministro di Dio che, oltre un decennio prima, aveva saputo cogliere il valore e il profondo significato dell'opera. A tu per tu nella calda estate romana, si parlò, infatti, anche de Il potere e la gloria (1940): all'inglese che gli ricordava la condanna ricevuta, sorridendo Montini rispose: "Mister Greene, certe parti del suo romanzo non possono non offendere alcuni cattolici, ma lei non dovrebbe attribuire alcuna importanza a questo".
Nato a Berkhamstead nel Hertfordshire e compiuti gli studi al Balliol College di Oxford, Green lavorò inizialmente come giornalista (al "Nottingham Journal", al "Times" e infine allo "Spectator"). Quindi, fu alle dipendenze del Ministero degli esteri, ricoprendo il ruolo che tanto spazio avrà in molti dei suoi romanzi: fu una spia al servizio di sua maestà. Soprattutto, però, in questi anni, si era già verificato l'evento decisivo della sua vita, ricco di implicazioni sulla sua produzione letteraria: la conversione al cattolicesimo. Il tramite fu una donna. Lavorando al "Nottingham Journal", infatti, Greene aveva avviato una fitta corrispondenza con Viviene Dayrell-Browning, a sua volta convertitasi al cattolicesimo. L'incontro porterà nel febbraio del 1926 al battesimo di Greene e, l'anno dopo, al loro matrimonio.
È del 1938 il primo romanzo del ciclo cattolico (La roccia di Brighton), ciclo che da subito si delinea nei suoi inconfondibili tratti: l'imprinting protestante e una certa tristezza puritana si combinano con la luce del cattolicesimo. Se il protagonista dei suoi romanzi è l'uomo moderno corrotto, cacciato e disperato, preda dell'ansia e della paura, circondato e braccato dal male, la presenza di Dio, amorevole e salvifica, è comunque una certezza. "Sono uno scrittore al quale è capitato di essere cattolico", ripeteva Greene: sono gli incontri e le esperienze della vita, le delusioni, le speranze, i desideri realizzati e quelli che si perdono per la via, a condire le pagine della sua letteratura, a dipingere sulla carta intrecci che sono, al contempo, molto più profondi e carichi di speranza di quanto non sia immediatamente percepibile.
Uno dei tratti distintivi del suo essere cattolico è ravvisabile nell'atteggiamento di grande compassione che Greene nutre verso la debolezza e la fragilità degli uomini. Il suo messaggio è stato perfettamente colto da Charles Moeller, autore della monumentale Letteratura moderna e cristianesimo: "L'opera di Greene altro non è che un commento alla parola divina: non giudicate. Non giudicate il mondo che vi sembra abbandonato da Dio: esso è abitato da Dio. Non giudicate l'umanità che in apparenza ha ucciso Dio: essa è salvata da Dio. Non giudicate la sconfitta di Dio, calpestato nelle sue istituzioni che vengono abbandonate al demonio, deriso nella debolezza dei sacramenti: la potenza e la gloria di Dio vi sono presenti". Come dice Scobie ne Il nocciolo della questione (1948), "Per essere veramente umano, tu devi bere il tuo calice fino alla feccia. Se una volta sei fortunato, e un'altra volta codardo, il calice ti vien presentato una terza".
È esattamente quanto fa il protagonista de Il potere e la gloria, il prete che nel Messico insanguinato dalla rivoluzione, tenta di sfuggire alle autorità che perseguitano, fucilando o costringendo alle nozze i ministri di Dio. Questa figura è l'autentico capolavoro di Greene: il prete, infatti, è un peccatore ("era un cattivo prete, lo sapeva. La gente aveva un nomignolo per quelli come lui: preti spugna"). Lentamente ma inesorabilmente, il peccato arrugginisce e corrode la sua vita. "Non era che l'ennesima resa. Gli anni alle sue spalle erano disseminati di analoghe capitolazioni (...). La sua vita quotidiana si era riempita di crepe, come una piaga, e la dimenticanza si infiltrava nelle fessure spazzando via questo e quell'altro". Del resto, quando già abbiamo appreso del suo alcolismo e dell'esistenza di una figlia concepita in una sera in cui era ubriaco, scopriamo quello che è in realtà il suo vero peccato: l'orgoglio.
Dio sembra assente in questo romanzo (come in tutto il mondo raccontato da Green). Lo Stato tenta di estirparlo, il comportamento dei suoi ministri fa di tutto per bestemmiarlo, Dio, infine, sembra sopraffatto dalla superstizione, dall'ignoranza e dalla cattiveria. Eppure, le pagine traboccano della presenza di Dio. "Era per quel mondo che Cristo era morto; quanto più male si vedeva e si sentiva in giro, tanto più grande era la gloria circonfusa attorno alla sua morte. È troppo facile morire per le cose buone o belle, per la patria, i figli, la civiltà... ma ci voleva un Dio, per morire per gli indifferenti e i corrotti".
Qualche giorno prima di essere giustiziato, il prete spiega al tenente che l'ha catturato la grande differenza tra i rivoluzionari atei e la rivoluzione della fede. Nelle prime i rivoluzionari debbono necessariamente essere buoni, mentre "anche se tutti i preti fossero come me, ubriaconi, vigliacchi, avidi, questo non cambierebbe nulla, perché essi potranno sempre dare Dio agli uomini". Il prete spugna, del resto, non è braccato solo dalla polizia, ma anche dalla sua coscienza, da Dio: come ha scritto Paul Rostenne, il suo destino diventa così una vocazione. Proprio in quest'ottica, anch'egli è un testimone dell'esistenza e dell'amore di Dio. Nell'imminenza dell'esecuzione, non ha paura né della dannazione eterna, né del dolore fisico: "Provava solo un'immensa delusione di doversi presentare a Dio a mani vuote, senza un'opera da offrire. Gli pareva, in quel momento, che sarebbe stato così facile essere un santo. Sarebbero bastati un po' di autodisciplina e un po' di coraggio. Si sentiva come chi, per pochi secondi, avesse mancato l'appuntamento con la felicità. Adesso sapeva che, alla fine, una sola cosa conta veramente: essere santi". Il potere e la gloria manifesta la forza soprannaturale del paradosso cristiano. Avere fede è credere che Dio non tace, che Dio non abbandona i suoi figli. Per questo, il peccato peggiore, "il peccato imperdonabile", è la disperazione.
In La fine dell'avventura (1951) Greene racconta una storia di conversione. Una bomba cade sopra la casa in cui si trovano l'adultera Sara Miller e il suo amante. Quando la donna, che è stata battezzata ma non lo sa, scopre l'uomo sepolto dalle macerie e lo crede morto, fa una cosa inspiegabile: inginocchiatasi, implora Dio, quel Dio che non conosce e al quale non crede, di salvare l'amante, impegnandosi in cambio a non vederlo mai più. Ebbene, qualche minuto dopo, scopre che in realtà Maurice è vivo. Sebbene non voglia mantener fede a quella promessa, non rivedrà più l'uomo. Per questo Sara si ritrova a odiare quel Dio, al quale continua a essere sicura di non credere, che le sta sottraendo la sua felicità. Ma proprio odiandolo perché l'ha presa alla lettera, la donna capisce che in realtà crede in Lui "perché non si può odiare dell'aria", (similmente accadrà a Maurice, dopo la morte di Sara). Come i due amanti, così fa anche il mondo.
In diverse forme e con variopinte sfumature Graham Greene ci suggerisce che la conversione è un processo costante. Convertirsi è attraversare e riattraversare il mondo, le sue crudeltà, i suoi silenzi e le fitte tenebre, in un continuo colloquio con Dio.
(©L'Osservatore Romano - 30 agosto 2008) __________________________________________________
 |
| |
| | | OFFLINE | Post: 11.290 | Registrato il: 03/10/2008
Registrato il: 01/11/2008 | Sesso: Maschile | |
|
Storie di conversione: Elizaveta Pilenko
La terrorista che reinventò
il monachesimo ortodosso di Adriano Dell'AstaElizaveta Pilenko aveva avuto un'infanzia sicuramente felice; nata nel 1891 in una famiglia di origini nobili e con relazioni altolocate, qualche biografo potrebbe immaginarla, bambina, a San Pietroburgo, sulle ginocchia di uno dei frequentatori abituali di casa Pilenko, Konstantin Pobedonoscev, l'onnipotente procuratore generale del Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa, conservatore e con una fama pesante di antisemita. Alla luce di questo inizio, molto più difficile sarebbe immaginare la fine che fece qualche decennio dopo quella che nel frattempo era divenuta monaca con il nome di Madre Marija: morì martire a Ravensbruck dove i nazisti l'avevano gettata per l'aiuto offerto agli ebrei parigini e dove lei, il 31 marzo 1945 (il giorno prima era il venerdì santo) si sarebbe offerta di prendere il posto di un'altra donna selezionata per la camera a gas.
Ma ancor più difficile a questo punto sarebbe immaginare la strada che portò Elizaveta alla santità (Madre Marija è stata infatti canonizzata dalla Chiesa ortodossa nel 2004).
 Nel 1906 Elizaveta perde il padre, Jurij: "Mio padre è morto. Nella mia testa pensavo: nessuno ha bisogno di questa morte. È un'ingiustizia. Se non c'è un Dio giusto, non c'è nessun Dio". La fede è perduta o, comunque, si oscura. Elizaveta comincia ad avere altre frequentazioni, scrive poesie, diventa amica del grande Blok; nel 1910 si sposa, con un giovane avvocato, marxista e alcolizzato, Dmitrij Kuz'min-Karavaev: nel giro di tre anni divorziano (romanzo nel romanzo: Dmitrij dopo la rivoluzione cambierà radicalmente vita e diventerà sacerdote cattolico). Poi c'è una relazione con un uomo rimasto sconosciuto dal quale ha una figlia (Gajana, che nel 1936 morirà di tifo); e poi ci sono la guerra e la rivoluzione; Elizaveta si impegna con il partito dei socialisti rivoluzionari, uno dei più decisi, sin dalle sue origini, nella teorizzazione e nella pratica del terrorismo come metodo "normale" di lotta politica. Lei non lancia certo bombe, ma è come rappresentante di questo partito che diventa sindaco di Anapa: ed è così la prima donna nella storia russa a svolgere un simile ruolo. Poi viene l'arresto, da parte dei bianchi che l'accusano di aver collaborato coi bolscevichi, e c'è un secondo matrimonio, con Daniil Skobcov, un membro del tribunale che doveva giudicarla, dal quale avrà due figli, Jurij e Anastasija. Alla fine i bolscevichi vincono ed Elizaveta, con la sua famiglia è costretta all'emigrazione; dopo questi anni di avventure e di azzardi saranno altri anni di stenti e di sofferenze, ma anche di una nuova scoperta. Nel 1906 Elizaveta perde il padre, Jurij: "Mio padre è morto. Nella mia testa pensavo: nessuno ha bisogno di questa morte. È un'ingiustizia. Se non c'è un Dio giusto, non c'è nessun Dio". La fede è perduta o, comunque, si oscura. Elizaveta comincia ad avere altre frequentazioni, scrive poesie, diventa amica del grande Blok; nel 1910 si sposa, con un giovane avvocato, marxista e alcolizzato, Dmitrij Kuz'min-Karavaev: nel giro di tre anni divorziano (romanzo nel romanzo: Dmitrij dopo la rivoluzione cambierà radicalmente vita e diventerà sacerdote cattolico). Poi c'è una relazione con un uomo rimasto sconosciuto dal quale ha una figlia (Gajana, che nel 1936 morirà di tifo); e poi ci sono la guerra e la rivoluzione; Elizaveta si impegna con il partito dei socialisti rivoluzionari, uno dei più decisi, sin dalle sue origini, nella teorizzazione e nella pratica del terrorismo come metodo "normale" di lotta politica. Lei non lancia certo bombe, ma è come rappresentante di questo partito che diventa sindaco di Anapa: ed è così la prima donna nella storia russa a svolgere un simile ruolo. Poi viene l'arresto, da parte dei bianchi che l'accusano di aver collaborato coi bolscevichi, e c'è un secondo matrimonio, con Daniil Skobcov, un membro del tribunale che doveva giudicarla, dal quale avrà due figli, Jurij e Anastasija. Alla fine i bolscevichi vincono ed Elizaveta, con la sua famiglia è costretta all'emigrazione; dopo questi anni di avventure e di azzardi saranno altri anni di stenti e di sofferenze, ma anche di una nuova scoperta.
Nel 1926, a Parigi, a soli quattro anni, Anastasija muore di meningite; per la madre è un dolore tremendo: ha perso tutto, la ricchezza dell'infanzia, i sogni della rivoluzione, la patria, una figlia amatissima, nell'emigrazione le resta una libertà che sembra essere una strana e crudele presa in giro, fatta del puro vuoto. Ma qui, come per tanti altri russi che l'accompagnano a Parigi e che diverranno suoi amici (Berdjaev e Bulgakov su tutti), scatta inattesa un'intuizione: "A cosa ci impegna il dono della libertà che ci siamo trovati addosso? Noi siamo fuori dalla portata dei persecutori. E siamo stati liberati anche dalle tradizioni secolari. Siamo fuori da ogni consuetudine. Che sarà mai, un caso? Nel campo della vita spirituale non c'è posto per il caso, né ci sono epoche più o meno fortunate, ci sono invece dei segni che bisogna capire e delle vie che bisogna seguire. E noi siamo chiamati a grandi cose, perché siamo chiamati alla libertà".
Quello che era successo non era un accidente privo di senso e neppure più un male senza redenzione, ma la sfida della libertà, perché dal sacrificio di quanto v'era di più caro nascesse una vita nuova: privata della maternità naturale, coinvolta in qualcosa che è più che dolore, Elizaveta capisce di essere chiamata a diventare "madre di tutti"; è l'inizio di una nuova vita, con la vocazione a una donazione totale che si svilupperà nelle modalità più diverse.
Innanzitutto è una passione senza limiti per l'umanità, che la porta a cercare nuovi figli là dove la sofferenza è più estrema e disperata, tra i diseredati e gli emarginati: disoccupati, malati, folli diventano la sua famiglia. È la vittoria che nasce dalle più tremende sconfitte, quando "l'uomo è posto di fronte a una scelta inevitabile: il tepore della sua dimora terrena, o lo spazio sconfinato dell'eternità, nel quale esiste un solo punto solido e certo, e questo punto solido e certo è la croce".
Questo cammino in compagnia della croce, sospeso alla croce, ha un primo punto fermo nel 1932, quando Elizaveta, ottenuto il divorzio religioso, prende i voti, con il nome monastico di Marija, in onore di santa Maria Egiziaca.
 Il passato turbolento è ormai alle spalle, ma il cuore è quello che è, e Marija resta una "monaca un poco selvaggia", che fuma in pubblico e gira all'alba per i mercati generali in cerca di qualcosa per i suoi poveri; la disciplina tradizionale, in un eremo isolato o in un comune monastero, le starebbe stretta: "Tagliarsi fuori dal mondo in nome dell'ascetismo è una forma raffinata di egoismo". E poi le condizioni in cui si trova l'emigrazione russa in Europa occidentale sono davvero nuove; e qui, ancora una volta, scatta l'intuizione della fede: "Bisogna camminare sulle acque. San Pietro lo fece e non annegò. Naturalmente tenersi a riva è più sicuro, ma si può anche non arrivare mai a destinazione". Il passato turbolento è ormai alle spalle, ma il cuore è quello che è, e Marija resta una "monaca un poco selvaggia", che fuma in pubblico e gira all'alba per i mercati generali in cerca di qualcosa per i suoi poveri; la disciplina tradizionale, in un eremo isolato o in un comune monastero, le starebbe stretta: "Tagliarsi fuori dal mondo in nome dell'ascetismo è una forma raffinata di egoismo". E poi le condizioni in cui si trova l'emigrazione russa in Europa occidentale sono davvero nuove; e qui, ancora una volta, scatta l'intuizione della fede: "Bisogna camminare sulle acque. San Pietro lo fece e non annegò. Naturalmente tenersi a riva è più sicuro, ma si può anche non arrivare mai a destinazione".
La nuova strada che viene inventata per "camminare sulle acque" è il monachesimo nel mondo; il monaco, amando Dio sopra ogni cosa, non rinuncia al mondo ma lo offre al suo creatore stando dentro al mondo stesso: non c'è più nessuna rinuncia, ma non c'è neppure una confusione con il mondo, la riduzione della Chiesa a un'istituzione benefica: "Bisogna che ogni nostra iniziativa diventi l'opera comune di tutti quelli che ne fruiscono e non sia invece un'opera benefica come tante, dove alcuni fanno del bene e presentano il resoconto e altri ricevono la beneficenza per lasciare il posto ad altri". Al di là di vecchi divieti e di nuovi sogni rivoluzionari, si tratta di un'intuizione creativa nella quale l'uomo torna a stringere tra Dio e il mondo "un legame che nulla potrà rompere". L'attività caritativa di Madre Marija la porta ad aprire ospizi, sanatori e convitti, il più famoso dei quali è quello di rue de Lourmel, 77: "è uno strano pandemonio: ci sono ragazze, pazzi, sfrattati, disoccupati e adesso due cori, quello dell'Opera russa e uno gregoriano, un centro missionario e funzioni in cappella a mattina e sera". Quello che a molti appare un caos, per Madre Marija è il compiersi della vocazione cristiana: "All'inizio nulla è trasfigurato. Alla fine non c'è nulla che non possa essere trasfigurato".
Il 27 settembre 1935, la storia di Madre Marija trova un altro punto fermo: per meglio corrispondere a questa vocazione viene fondata l'Azione Ortodossa: il nome è suggerito da Berdjaev, l'approvazione ecclesiastica viene dal metropolita Evlogij, una delle massime autorità della comunità russa emigrata, tra i fondatori ci sono i nomi più luminosi della cultura religiosa russa all'estero. Viene offerto un aiuto materiale a chiunque ne abbia bisogno (dal piatto di minestra per l'ultimo dei vagabondi, al lavoro o alla casa per chi non riesce a far fronte alle difficoltà economiche che, anche nella Parigi degli anni Trenta, per primi colpiscono gli immigrati); ma non ci si limita a questo, vengono organizzate conferenze per tener viva la memoria della propria tradizione e rendere sempre più cosciente il compito del cristiano di trasfigurare tutto il mondo. Madre Marija non si risparmia di fronte a nulla: "Il mondo crede che se si dà il proprio amore si resta depauperati di ciò che si è dato. È vero il contrario: tutta la ricchezza spirituale donata agli altri non solo ritorna al donatore, ma cresce e si rinvigorisce".
Più risponde alla provocazione della realtà per riportarla a Cristo e più Madre Marija diventa sensibile ai bisogni del mondo. E tanto più diventa sensibile a questi bisogni, tanto più chi la incontra ne viene conquistato, ne accetta i consigli o la segue, come accade quando si reca in visita a un gruppo di minatori dei Pirenei e, inizialmente, viene accolta con ostilità da chi sospetta che abbia l'intenzione di fare un "pio sermone" e l'invita piuttosto a dare una pulita alla baracca in cui vivono; lei non si scompone e sostituisce la progettata conferenza con un umile lavaggio dei pavimenti (dopo di che i minatori l'ascolteranno con una disponibilità ben diversa, e uno di loro dirà che solo le sue parole l'avevano distolto da un suicidio a lungo meditato).
La stessa dinamica si ripete quando i nazisti arrivano a Parigi e iniziano le persecuzioni razziali. Madre Marija e i suoi amici non possono accettare un mondo dove "l'umanità intorpidita esulta per miseri successi e si amareggia per piccoli insuccessi, rinnega la propria elezione e si tira con zelo e precisione il coperchio della tomba sulla testa"; nessuno di loro può restare insensibile di fronte alla nuova situazione e per l'Azione Ortodossa" è del tutto naturale contrapporre alle nuove divisioni "il mistero dell'autentica comunione umana, che si radica nella comunione della Trinità", e così si cerca di soccorrere in ogni modo gli ebrei, fornendo loro rifugi, documenti contraffatti, soprattutto certificati di battesimo falsi. La repressione non tarda ad arrivare: con Madre Marija verranno arrestati, tra gli altri, suo figlio Jurij e l'assistente spirituale padre Dimitrij Klepinin. Tutti moriranno in campo di concentramento rivivendo nella propria morte l'amore di Cristo: "per amore verso la creazione Dio ha destinato il proprio Figlio alla morte sulla croce, non perché non potesse redimerci in altro modo, ma per insegnarci con ciò la ricchezza del suo amore", aveva detto Madre Marija e, pur conoscendo perfettamente i rischi di quello che stava facendo, aveva intrapreso gli ultimi passi della sua esistenza proprio per questo amore e con questo amore per Cristo. Come aveva scritto dopo la morte della figlia Gajana: "No, morte, non te amavo / Ma quanto è di più vivo al mondo: l'eternità / E quanto v'è di più mortale al mondo: vivere".
(©L'Osservatore Romano - 1-2 settembre 2008) __________________________________________________
 |
| |
| | | OFFLINE | Post: 11.290 | Registrato il: 03/10/2008
Registrato il: 01/11/2008 | Sesso: Maschile | |
|
Storie di conversione: Baruch
Il rabbino di Tolosa e il suo amico inquisitore di Anna Foa
Nel 1320, mentre Papa Giovanni xxii regnava ad Avignone, la crociata dei Pastorelli dilagò nel Sud della Francia. Una crociata di marginali, adolescenti, contadini, che attaccò le istituzioni ecclesiastiche e si rivolse in particolare contro gli ebrei, le cui comunità in Provenza furono attaccate e distrutte. Gli ebrei furono costretti a convertirsi sul filo della spada, chi si rifiutava venne massacrato.
Un episodio di violenza indiscriminata dal basso, non condiviso, anzi avversato e temuto dalle alte gerarchie ecclesiastiche, ma che incontrò in molte parti il favore del clero più basso.
A Tolosa, i Pastorelli arrivarono nel mese di giugno. L'ebreo Baruch, un rabbino di origine tedesca molto famoso per il suo sapere, era nella sua stanza intento a studiare quando il quartiere ebraico fu invaso dalla folla dei Pastorelli e del popolino che li seguiva.
Baruch fu portato nella cattedrale, dove due preti lo spinsero a battezzarsi subito, se voleva evitare di essere messo a morte. Baruch chiese allora di essere portato da un frate domenicano del convento, che voleva fosse suo padrino nel battesimo. Era un suo amico, una persona con cui era solito discutere e studiare, e sperava di potersi, tramite suo, salvare senza dover accettare il battesimo.
La folla in tumulto impedì però che i due preti riuscissero a fargli raggiungere il convento. Sotto una minaccia di morte così immediata, in mezzo ai cadaveri degli ebrei che avevano rifiutato il battesimo, Baruch fu così portato al fonte battesimale e fu battezzato all'istante, prendendo il nome di Giovanni.
Pochi giorni dopo, allontanatisi i Pastorelli, Baruch lasciò Tolosa e tornò alla sua religione. Il battesimo era stato un atto forzato, la sua conversione era avvenuta sotto la minaccia diretta di morte. Era un uomo coscienzioso, tuttavia, e volle sistemare le cose per bene, a scanso di ulteriori sorprese.
Si recò quindi dal locale inquisitore, e gli espose il suo caso. L'inquisitore non ebbe dubbi: si trattava di un battesimo forzato, quindi invalido secondo il diritto canonico. Baruch tornò ai suoi studi, tranquillo, anche se lasciò Tolosa per Pamiers.
Pochi mesi dopo, il cistercense Jacques Fournier, che nel 1334 diverrà Papa con il nome di Benedetto xii, divenne vescovo di Pamiers. I suoi registri d'Inquisizione, conservati nella Biblioteca Vaticana e pubblicati nel 1965 da Jacques Duvernoy, ci descrivono la sua intensa attività contro i Catari, il suo principale obiettivo nella zona.
L'unico ebreo da lui processato fu Baruch, e molte pagine del suo registro sono dedicate al suo caso.
Jacques Fournier era un inquisitore colto, molto addentro ai meccanismi del diritto canonico, a differenza, evidentemente, del locale inquisitore a cui Baruch si era rivolto per ottenere la conferma dell'invalidità del suo battesimo. Venuto a conoscenza del suo caso, convocò Baruch e gli comunicò che la sua conversione, dal punto di vista del diritto canonico, non era affatto nulla.
Avrebbe dovuto quindi tornare al cristianesimo, e abbandonare l'ebraismo, o sarebbe stato considerato come un apostata e bruciato sul rogo. Ma perché una conversione sulla punta della spada era considerata valida dal diritto canonico nel 1320, mentre non lo era nel 1096, quando i vescovi della Germania renana avevano consentito il ritorno all'ebraismo di quanti si erano convertiti durante i pogrom operati dalle bande marginali della Prima crociata?
In realtà, è vero che le norme stavano cambiando, e in un certo senso l'inquisitore locale non era davvero ignorante del diritto canonico, ma semplicemente non ne conoscevano i più recenti sviluppi, che prevedevano una distinzione fra forza assoluta e forza relativa.
La forza assoluta era quella che comportava che l'acqua del battesimo fosse gettata su qualcuno mentre costui continuava a protestare ad alta voce di non volersi battezzare. In questo caso, il sacramento non era valido, il sigillo del battesimo non era impresso. In tutti gli altri casi, il battesimo era valido, il sigillo era impresso, l'ebreo o l'infedele diveniva cristiano. Anche il battesimo imposto con la spada ricadeva in questa seconda categoria, perché lasciava pur sempre la scelta fra la conversione o la morte.
Informato da Jacques Fournier di queste norme, Baruch comprese rapidamente di non avere scelta, a meno di non voler affrontare il rogo come apostata.
Ma volle, nondimeno, dire la sua, e chiese di essere convinto delle verità della fede cristiana, prima di accettarle. Volle, insomma, trasformare un battesimo forzato in un battesimo liberamente accettato.
O forse volle soltanto prendersi una rivincita e disputare di teologia con l'inquisitore, come altre volte aveva discusso con il suo amico domenicano, alla pari? Oppure, c'era una qualche connessione fra la sua frequentazione del frate domenicano, la sua conversione forzata e la sua scelta di preferire la conversione al martirio? Non lo sappiamo, ma sappiamo che fu, in qualche settimana, convinto dei principi basilari della fede cristiana, della Trinità, della messianicità di Cristo. E divenne cristiano. Passò il resto della sua vita, riteniamo, come un cristiano.
Non lo sappiamo con certezza, perché il registro di Jacques Fournier non lo nomina più.
Ma ci resta questa storia incredibile, di un rabbino convertito a forza e di un inquisitore destinato ad esser Papa che disputano sottilmente all'ombra di un rogo, per fortuna solo minacciato. Non sappiamo davvero se Baruch si sia davvero convinto e sia diventato cristiano nel cuore, certo lo rimase di fatto.
Era troppo pericoloso ormai, per lui, compiere qualsiasi atto sia pur lontanamente giudaizzante. Ma ci piace immaginare che, allontanatosi Fournier a scovare Catari nelle vicinanze, il neofita sia tornato alle conversazioni con il suo amico domenicano, e forse, a volte, si siano ambedue dimenticati, nella foga, di essere ormai della stessa religione, ed abbiano ricominciato a discutere come se l'uno avesse già il suo Messia e l'altro, l'ebreo Baruch, ancora lo attendesse.
(©L'Osservatore Romano - 3 settembre 2008) __________________________________________________
 |
| |
| | | OFFLINE | Post: 11.290 | Registrato il: 03/10/2008
Registrato il: 01/11/2008 | Sesso: Maschile | |
|
Storie di conversione: Hermann Cohen
E il pianista dissoluto
divenne padre Agostino Maria di Cristiana Dobner
L'Italia conta una tradizione di salotti fin dal Cinquecento: le poetesse raccoglievano attorno a sé amici e letterati: Veronica Franco, a Venezia; Tullia d'Aragona, Vittoria Colonna a Roma; Caterina da San Celso a Milano dove pure Cecilia Gallerana-Bergamini tenne salotto artistico, letterario e poetico; mentre Clelia del Grillo, poliglotta d'eccezione, consorte del conte Giovanni Benedetto Borromeo, in via Rugabella tenne aperte le sue sale alla cospirazione di alcuni nobili desiderosi del ritorno alla monarchia spagnola. Il conte Biancani, uno dei congiurati, venne perseguitato e giustiziato. Le signore milanesi furono prese da una autentica vena salottiera, basti solo qualche accenno: Annetta Vadori, Bianca Milesi (con circolo dichiaratamente politico e carbonaro).
Il salotto della contessa Maffei fu un punto di incontro letterario artistico e politico per la Milano della seconda metà del secolo xix, realmente "un grande affresco della società milanese". I concerti erano famosissimi, vi suonò lo stesso Liszt accompagnato da due persone, per molti aspetti interessanti: la contessa d'Agoult, sua convivente e allora incinta di quella che sarà Cosima von Bülow e poi amante di Wagner, e Hermann. Chi mai è costui?
 Nato nel 1821 nella famiglia ebraica dei facoltosi banchieri Cohen, residente ad Amburgo, Hermann ricevette una raffinata educazione, mentre la sua grande sensibilità di fanciullo si rivelava anche nell'ambito religioso, i salmi infatti gli suscitavano "emozioni e tenerezze". Disposizione interiore che dice passioni e sentimenti e si manifestava in "una grande attrazione per la preghiera". Nato nel 1821 nella famiglia ebraica dei facoltosi banchieri Cohen, residente ad Amburgo, Hermann ricevette una raffinata educazione, mentre la sua grande sensibilità di fanciullo si rivelava anche nell'ambito religioso, i salmi infatti gli suscitavano "emozioni e tenerezze". Disposizione interiore che dice passioni e sentimenti e si manifestava in "una grande attrazione per la preghiera".
Talento precoce ed enfant prodige, non lasciò tuttavia un segno nella storia della musica pari al dono ricevuto. Pianista eccellente, docente al Conservatorio di Ginevra a soli 15 anni, mancò tuttavia di una formazione rigorosa e austera. Superata una difficoltà iniziale in famiglia verso lo studio della musica, iniziò prestissimo a esibirsi, anche per il dissesto finanziario che mutò le condizioni dei Cohen. Per la mancanza del padre nell'educazione dei figli e per l'ambizione della madre, Hermann si infatuò di se stesso. Adulato e portato da un corrotto maestro "al cabaret e dai suoi amici, per mostrare il piccolo prodigio", il ragazzino perdette la misura di sé e delle relazioni umane. Si trasferì a Parigi a soli 13 anni e divenne un piccolo, maleducato, tiranno. Nei salotti parigini veniva conclamato genio ed essere straordinario. Gli riuscì di diventare allievo di Franz Liszt e i due ben presto divennero inseparabili. Liszt aveva raccolto intorno a sé le più celebri personalità dell'epoca: Lamennais e George Sand. Hermann adolescente, corrotto, dedito al gioco e agli stravizi; lo vediamo descritto in termini elogiativi da Liszt a George Sand: "È il nostro vecchio camerata, il giovane Hermann Cohen di Amburgo, da lei denominato "Puzzi" che accompagnava il principe Belgiojoso. Il suo aspetto pallido e melanconico, i suoi bei capelli neri e la sua vita esile contrastavano poeticamente con le forme sicure, la chioma bionda e il volto aperto e colorito del principe. Il caro ragazzo ha dato di nuovo prova di quell'intesa precoce, di quel sentimento profondo dell'arte che già lo staglia dalla linea dei pianisti ordinari e che mi fanno presagire per lui un avvenire brillante e fecondo". La realtà gli avrebbe dato torto, almeno in quanto a successo pianistico. Puzzi, "il melanconico", spreca gioventù, talento e denaro. Nel corso di un viaggio il trio giunse a Milano, la contessina Maffei racconta: "L'Hermann (...) quando venne nel mio salotto, non aveva ancora diciassette anni. Il suo sorriso, quasi infantile, mi par di vederlo, e sua figlia, che voi conoscete, l'ha ereditato".
Le strade di questi personaggi poi si separarono, brogli, interessi di carriera, affari di donne, tinsero a fosche tinte la gioventù di Hermann che, nel frattempo, dilapidò quanto guadagnava, quando il gioco e i vizi gli lasciavano qualche momento di lucidità.
"Qualcuno" però intervenne. Nel maggio del 1848, a Parigi nella chiesa di Santa Valeria, Hermann sostituì l'amico principe della Moskowa nella direzione del coro: "Quando giunse il momento della benedizione, per quanto non fossi per nulla disposto a inginocchiarmi come il resto dell'assemblea, sentii un turbamento indefinibile: la mia anima stordita e distratta dall'agitazione del mondo, si ritrovò, per così dire e fu come cosciente che in lei avveniva una cosa del tutto sconosciuta precedentemente. Fui, senza dubitare, o meglio senza la partecipazione della mia volontà, fui spinto a curvarmi. Ritornatovi il venerdì successivo, venni impressionato assolutamente nello stesso modo e fui colpito dall'idea repentina di farmi cattolico".
Egli ricorderà sempre questi momenti di grazia: "Mese di Maria, mese dei fiori... mese della mia conversione, io ti saluto! Sì, amo Maria!... Ho deciso di prenderla per compagna della mia vita, per "arca della mia alleanza", per porta del mio cielo, per consolatrice delle mie afflizioni".
Il 28 agosto 1847 egli è pronto ad accogliere la grazia. Sarà un'esplosione di sensi interiori: egli vede, sente, viene toccato, gusta, in un modo che gli si farà familiare. Scrive al padre Ratisbonne, suo direttore spirituale: "Provai una commozione così viva, così potente che saprei meglio paragonarla solo allo choc di una macchina elettrica. Gli occhi del mio corpo si chiusero, e nello stesso tempo si aprirono quelli dell'anima a una luce soprannaturale e divina. Questa luminosità si diffuse in tutto il mio essere, Dio lo Spirito Santo, come per sigillare la sua promessa, discese dall'alto dei cieli su di me, mi prende per mano e mostra al mio sguardo rapito in estasi, dirigendolo verso l'alto, quanto mai un essere finito potrà comprendere (...) l'Infinito... Sì. Io l'ho visto (chiusi gli occhi del mio corpo, ma dilatati di felicità quelli della mia anima)".
 Hermann, ora trasformato, avvicinò gli amici d'un tempo, e anche George Sand che lo ricordava come l'amato Puzzi. Si sedettero al pianoforte, Hermann suonò qualche nota, lasciò cadere qualche parola. George l'ascoltò con attenzione, poi la collera ebbe il sopravvento e si impadronì di lei. Si alzò bruscamente e gridò: "Vattene, non sei che un monaco villano". Anche la sua famiglia e l'ambiente ebraico reagirono con vigore a quella che fu ritenuta un'apostasia e un'infatuazione. Hermann, ora trasformato, avvicinò gli amici d'un tempo, e anche George Sand che lo ricordava come l'amato Puzzi. Si sedettero al pianoforte, Hermann suonò qualche nota, lasciò cadere qualche parola. George l'ascoltò con attenzione, poi la collera ebbe il sopravvento e si impadronì di lei. Si alzò bruscamente e gridò: "Vattene, non sei che un monaco villano". Anche la sua famiglia e l'ambiente ebraico reagirono con vigore a quella che fu ritenuta un'apostasia e un'infatuazione.
Hermann il 22 novembre 1848 aveva fondato l'Adorazione notturna: una catena di adoratori che si susseguono per tutta la notte. Gli restava però di affrontare il suo passato, parecchi anni più tardi la contessa Maffei raccontò: "L'Hermann, passato di vicenda in vicenda, ricercò della signorina amata, mandando apposta, fin dai Pirenei a Milano, una sorella; e allora avvenne una scena commoventissima fra la povera abbandonata (che avea avuta da lui una bambina) e la sorella del giovane tedesco".
Dio incalzò ancora, "10 novembre 1847: 27° giorno della mia nascita: rinnovato davanti all'altare della Santa Vergine il voto di prendere gli ordini e di consacrarmi al servizio del Signore appena i miei doveri verso i miei creditori mi lasceranno libero". Hermann desidera diventare carmelitano, ma sarà accettato? La sua origine ebraica non costituirà un ostacolo? Si portò perciò a Roma per perorare la sua causa e ottenuto il consenso ruppe ogni indugio: il 16 luglio partì per il noviziato carmelitano: "Ora, dopo il mio ritorno dall'Italia, il Santissimo Sacramento è stato messo proprio nell'oratorio del nostro piccolo noviziato, esso è quindi divenuto un autentico braciere d'amore. Nostro Signore riposa a qualche passo dalle nostre celle, Egli ci circonda come un muro di fuoco".
La vita mutata e la scelta religiosa di Puzzi rimbalzarono nel salotto Maffei: "Quando a Milano si seppe che il prediletto allievo del Liszt e il padre d'una bruna cara bambina era diventato "padre Agostino Maria" e saliva sui pulpiti spiegando un'eloquenza sublime, non si fecero troppe meraviglie, conoscendo il carattere e l'ingegno di lui".
L'emozione in Agostino Maria diventò polla d'acqua trasparente mentre si avvicinava il Sabato Santo, giorno della sua ordinazione sacerdotale, del 1851 (anno del Rigoletto per il mondo della musica), "mi trovo in un'emozione impossibile a comunicare: la felicità e un santo timore si dividono il mio cuore".
Divenuto sacerdote attraversò la Francia predicando come una colata lavica in fermento. Ma la sua salute, e per i passati trascorsi e per la sua dedizione senza limiti all'ideale abbracciato, era scossa e vacillante. Afflitto, oltre ai consueti disturbi, da una grave malattia agli occhi, padre Agostino Maria andò a Lourdes nel 1868 e venne graziato da Maria nell'ultimo giorno di un'intesa novena. Ricuperò la vista e il miracolo fu riconosciuto dai medici. "Non ho visto la Santa Vergine, ma ho provato alla Grotta tutte le impressioni della mia conversione".
Agostino Maria vivrà nel deserto carmelitano di Sant'Elia ma ne abbandonerà la vita nascosta al richiamo della carità.
Il carmelitano fu costretto a lasciare la sua amata Francia per non mettere in pericolo i confratelli nel corso della guerra franco prussiana, ma ottenne, egli tedesco, di soccorrere i prigionieri francesi a Spandau.
Fragile di salute, chiamato alla vita solitaria e silenziosa, Agostino Maria si dimenticò di se stesso e servì i prigionieri con delicata attenzione e premura materna. La sua debole fibra però cedette e si ammalò gravemente. Comprese che si avvicina il grande momento, il 20 gennaio 1871, chiese alla religiosa che lo assisteva di cantare il Te Deum e la Salve Regina.
La sua voce dapprima sonora, lentamente si affievolì: si spense nel canto e trapassò. La fiamma si staccò dal legno. Agostino entrò nell'"armata dei Santi, vestiti dei più splendenti colori dell'arcobaleno" come li aveva visti nel giorno del suo battesimo.
(©L'Osservatore Romano - 19 settembre 2008) __________________________________________________
 |
| |
| | | OFFLINE | Post: 145 | Registrato il: 30/09/2006
Registrato il: 25/11/2008 | Sesso: Maschile | |
|
Ragazzi mi ricordo il pianto a dirotto, quando capii che per 22 anni avevo preso Gesù per una creatura, compresi l'errore madornale dove mi ero andato a ficcare!! per cercare la "verità" in religioni americane!!
Quando mi accostai a Dio in fervida preghiera faccia a terra, LUI mi inondò del SUO amore e cominciai a piangere un pianto di liberazione.
![[SM=g7300]](https://im0.freeforumzone.it/up/0/0/3212000.gif)
Quante dottrine, quante ore, quanta energia spesa credendo di fare del bene, invece... mi pento per aver indotto altri a credere nell'impostura.
Adesso so che Gesù è perfettamente Dio, la seconda persona della SS Trinità, Grazie al fratello Cattolico Romano ho compreso l'importante ruolo della Beata Maria, alla comunione dei Santi, GRAZIE!! Dio, Grazie fratello! Cattolico Romano.
Dio ci Benedica. ![[SM=g7515]](https://im0.freeforumzone.it/up/0/15/1037070.gif) ![[SM=g8925]](https://im0.freeforumzone.it/up/0/25/2374050.gif) ![[SM=g8925]](https://im0.freeforumzone.it/up/0/25/2374050.gif) |
| |
| | | OFFLINE | Post: 11.290 | Registrato il: 03/10/2008
Registrato il: 01/11/2008 | Sesso: Maschile | |
|
Quante dottrine, quante ore, quanta energia spesa credendo di fare del bene, invece... mi pento per aver indotto altri a credere nell'impostura. Adesso so che Gesù è perfettamente Dio, la seconda persona della SS Trinità, Grazie al fratello Cattolico Romano ho compreso l'importante ruolo della Beata Maria, alla comunione dei Santi, GRAZIE!! Dio, Grazie fratello! Cattolico Romano.
Caro Roberto devo essere sincero, leggendo questa tua breve testimonianza mi hai commosso, non scherzo.
Comunque voglio ribadire anche se qualcuno può pensare che io stia facendo della falsa umiltà, che non sono stato io a farti comprendere il Mistero di Maria e dei Santi, ma è stato Gesù che ha trovato il tuo cuore aperto al suo amore e alla sua Verità, la Gloria sia sempre a Dio!
Noi siamo solo strumenti che molte volte agiscono in maniera non convenevole per il Vangelo del Signore...anche quando avremo fatto tutto quel che il Signore ci chiede saremo, dinanzi al suo Amore, servi inutili.
Grazie ancora Roberto e che Dio riempia il tuo cuore del Suo Amore e della Sua Pace, in Cristo Gesù, Nostro Signore e salvatore!
Amen!__________________________________________________
 |
| |
|
Trascrivo quel che ho letto sul libro di Vittorio Messori e Andrea Tornielli "Perchè credo"pag.290...
"Ho cosi' ricordato agli ignari, ma anche ai professori (...) che Alessandro Volta fu uomo da messa e rosario quotidiani, Andrè-Marie Ampère scrisse addirittura un libro, PROVE DELLA DIVINITA' DEL CRISTIANESIMO,Michael Faraday alternò la ricerca in laboratorio a predicazioni per strada del Vangelo, Luigi Galvani fu un devoto terziario francescano, Galileo Ferraris un militante rigorosoed esplicito del mondo cattolico torinese,Leòn Foucault un fervoroso convertito, ovviamente al cattolicesimo...Può bastare , almeno qto all'elettricità? Sennò,sono pronto a fornire analoghe liste per ogni ramo della scienza moderna.A cominciare da quel mitico padre che,secondo molti,ne fu Galileo Galilei, che mori' alla "Pascal"avendo chiesto tutti i sacramenti,avendo ricevuto una speciale benedizione papale( altro che persecuzione!) e la cui ultima parola,sussurrata nell'agonia e raccolta dalla figlia monaca, fu :"Gesù!"."
Bye Bye Cris ![[SM=g7340]](https://im0.freeforumzone.it/up/0/40/4205820.gif) |
| |
|
Blaise Pascal
--------------------------------------------------------------------------------
"Il pensiero fa la grandezza dell'uomo"
Ci sono nel tempo, nella storia dell’umanità, individui che paiono aver per missione la conoscenza e la divulgazione delle loro esperienze per il collettivo beneficio dell’umanità, uno di questi nacque a Clermon, Francia centrale, il 19 giugno del 1623.
Blaise Pascal è figlio di un alto magistrato di nome Étienne, uomo dotto ed onesto, che lo educò con affetto alle lettere classiche e ad una sana condotta.
Ebbe due sorelle, la maggiore, Gilberte, che nel 1662 scriverà una biografia morale del fratello e la minore, Jacqueline, che a ventisette anni entrerà nel monastero di Port-Royal, per la quale Blaise nutriva profonda ammirazione.
Sin dall’infanzia, Pascal dimostra un’acutezza ed un amore per il sapere fuori dal comune, tanto che il padre, incoraggiato dai portentosi risultati, finirà per dedicarsi interamente a lui.
Oltre alla grammatica, all’età di otto anni, Étienne incomincia col far conoscere al figlio le scienze ed il mondo fenomenico della natura; il fanciullo grazie ad una curiosità, frutto di una vigile ed attenta intelligenza, viene spinto a voler comprendere la ragione di ogni cosa, la sua mente non sembra soddisfarsi con nulla.
A tal proposito la sorella, nella sua biografia, dirà:
“[…]Mio fratello provava un grande piacere in questi colloqui, ma voleva sapere la ragione di tutte le cose; e poiché non sono tutte conosciute, quando mio padre non gliele diceva o gli diceva solo quelle che di solito si adducono, che propriamente sono ripieghi, ciò non lo accontentava;
egli infatti ebbe sempre un’ammirabile chiarezza di mente per discernere il falso;
e si può dire che sempre ed in tutte le cose la Verità è stata l’oggetto della sua mente, poiché nulla ha saputo e potuto soddisfarlo se non la conoscenza […]”.
Nel 1634, a undici anni, scrive il suo primo trattato sul fenomeno del suono!
Il padre si era sempre riservato di insegnare le matematiche in futuro, per non riempirgli la mente e rischiare di renderlo negligente rispetto alle materie umaniste.
Ma quando Blaise seppe che le scienze matematiche erano un mezzo per creare figure esatte e trovare le proporzioni che esse hanno fra loro, il ragazzo si mise, nelle ore libere, a pensare a quei concetti.
Così fu che, senza alcuna indicazione ed alcun libro, servendosi di bastoncini in legno, a quattordici anni arrivò da sé, alla trentaduesima preposizione del primo libro di Euclide!
D’ora in avanti studierà anche la logica e la fisica, a sedici anni scriverà un Trattato sulle coniche, il “Teorema di Pascal”.
Nel 1640 la famiglia si trasferisce in Normandia, dove il padre viene nominato commissario del re.
Per aiutare il genitore nei calcoli, crea la machine arithmétique; viene così inventata la prima calcolatrice della storia, definita “pascalina”!
Ma è il 1646 l’anno in cui avviene un cambiamento radicale in Pascal, la sua prima conversione.
Il tutto avviene per aver letto il Discorso sulla riforma dell’uomo interiore ed altri scritti dell’abate Saint-Cyran sulla pietà ed i doveri spirituali dell’individuo.
Entra in contatto con gli ideali giansenisti, con un cristianesimo austero d’impronta agostiniana.
Pascal sente il richiamo ad una vita santa, ma abbandona solo parzialmente i suoi studi matematici e fisici; inizia però a riflettere su Dio e sull’esistenza, su come impiegare i talenti donatigli per metterli al servizio di una causa più nobile delle speculazioni filosofiche o scientifiche rendendoli conformi alla Legge Universale.
Ne scaturirà una filosofia marcatamente esistenzialista.
Le sue ricerche proseguono, sullo spunto delle scoperte di Torricelli studia e fa esperimenti sul vuoto e sulle proprietà dei liquidi, e proprio sull’esistenza del vuoto ha una polemica con il padre gesuita Noël.
Nel 1647, a causa della salute cagionevole si concede un periodo di riposoin cui si distrae partecipando alla vita di società, certo più mondana di quella che era solito frequentare; entra nei circoli scientifici, discute e si confronta con altri ricercatori.
La volontà di cambiare le sue abitudini e di divenire più spirituale resta, Blaise continua a meditare e ragionare su problemi di tipo esistenziale, tanto che la sorella rimane toccata dai suoi discorsi e decide di abbandonare i vantaggi del mondo, consacrandosi a Dio divenendo monaca.
Il 23 novembre 1654, Pascal ha un’esperienza mistica che segnerà la sua definitiva conversione, verrà da lui definita “nuit de feu”, notte di fuoco, e sarà descritta nel “Memoriale”, un foglio che Pascal portava sempre cucito all’interno dei suoi abiti.
Si tratta di un’autentica rivelazione che darà inizio ad un progressivo cammino interiore:
"Fuoco Dio di Abramo Dio di Isacco Dio di Giacobbe non dei filosofi e dei dotti. Certezza. Certezza. Sentimento Gioia Pace Dio di Gesù Cristo Deum meum et Deum vostrum.
Il tuo Dio sarà il mio Dio. Oblio del mondo e di tutto, tranne Dio. Egli non si trova se non nelle vie indicate nel Vangelo. Grandezza dell'anima umana. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. Gioia, gioia, gioia, lacrime di gioia. Me ne sono separato".
Da allora la sua vita cambia, si ritira frequentemente a Port-Royal-des-Champs, dove trova pace e solitudine e comincia ad applicare su se stesso due principi: rinunciare ai piaceri ed al superfluo, si dedicherà per il resto della sua vita al sostegno dei poveri e dei malati.
Il suo stato di salute si aggrava, ma egli sempre, tiene fisso il proposito di mortificarsi e di esercitare la pietà, cercando di rendere il più conforme la sua vita a quella del Cristo.
Le problematiche esistenzialiste prendono il primo posto nelle sue riflessioni e nei suoi pensieri, che si fanno più chiari e precisi.
Egli vede la sua malattia come un’opportunità di maturazione interiore.
Uno degli aspetti del suo pensiero filosofico si basa sul fatto che l’intero genere umano, sulla terra, è in una condizione di miserabile sofferenza senza via d’uscita:
i desideri e le delusioni, la fatica, le ansie, così è per tutti dalla nascita alla morte, ogni sforzo è vano, il destino della vita umana è tracciato come parabola in declino.
L’uomo rischia però di essere soverchiato da questa realtà, qualora vi riflettesse senza trovare risposte; allora, per non pensarci, si dedica al mondo e ai divertimenti, (“devertere”= allontanare), ed è così che passa l’esistenza senza che ci si renda conto della situazione.
Da qui il bisogno di stare in compagnia, di evitare la solitudine, dei discorsi vani o di circostanza; si evince che l’indifferenza dell’umanità a problemi tanto fondamentali è in realtà una fuga da essi.
"Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l’ignoranza, hanno creduto meglio, per essere felici, di non pensarci".
Quando si presenta una condizione di malattia però, la situazione cambia, messo di fronte ad una realtà più percepibile, l’uomo è costretto a pensare alla sua miseria ed al rapporto col divino, in questo senso la sofferenza diviene spinta di crescita.
Resta però il fatto che anche chi vive negli agi e nei piaceri soffre a livello esistenziale (e quindi nel profondo) tanto quanto un povero od un malato, questo pur essendone apparentemente ignaro.
Tutto ciò rende l’idea di quanto triste sia la condizione umana, di tutta l’umanità (tanto da ispirare pietà), ed ecco che la filosofia esistenzialista di Pascal cerca di mettere a fuoco questi aspetti, insieme all’atteggiamento più consono per accettare e superare una condizione, che è per suo stesso dire, angosciosa.
"L’uomo è manifestamente nato per pensare; qui sta tutta la sua dignità e tutto il suo pregio;
e tutto il suo dovere sta nel pensare rettamente.
Ora, l’ordine del pensiero sta nel cominciare da se stesso, dal proprio autore e dal proprio fine.
Ma a che cosa pensa il mondo? Non pensa mai a questo,
ma a danzare, a suonare il liuto, a cantare, a scriver versi, a far tornei, a battersi, a diventar re, senza pensare che cos’è un re e che cos’è un uomo".
E’ anche vero per Blaise, che la Meta non si può raggiungere con un’improvvisa folgorazione, ma con una lenta ascesa, fatta di riflessioni e rinunce.
|
| |
|
Nelle sue esplorazioni interiori alla ricerca del senso della Vita, comprende che la ragione ha dei limiti ed è lui, scienziato, a dirci che quello da cercare non è il Dio dei dotti e dei sapienti, ma un Dio vivente che risiede nel cuore di ogni uomo e con il quale è possibile avere un rapporto personale e diretto.
Resterà celebre la frase: “Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce”.
Pascal diviene consapevole di come non vi sia problema al mondo che possa essere sganciato dalla ricerca di Dio, che avviene insieme alla ricerca della Fede.
Altra problematica affrontata è l’Infinito, che sfugge alla ragione e si può solo percepire, ancora una volta, l’aspetto intuitivo assume un ruolo determinante.
"Sono in un’ignoranza spaventosa di tutto … Da ogni parte vedo soltanto infiniti… Tutto quello che so è che debbo presto morire;
ma quel che ignoro di più è, appunto, questa stessa morte, che non posso evitare".
L’uomo è un nulla rispetto all’Infinito, ed è bene che se ne accorga prima possibile, scriverà nei suoi celebri “Pensieri”:
“Alla fine che cos’è l’uomo nella natura?
Un nulla rispetto all’Infinito, un tutto rispetto al nulla, una via di mezzo tra nulla e tutto;
infinitamente lontano dal comprendere gli estremi.
La fine delle cose e il loro principio gli sono invincibilmente nascosti in un impenetrabile segreto.
Ugualmente incapace di vedere il nulla da cui è tratto e l’Infinito nel quale è inghiottito, che cosa farà allora, se non scorgere qualche apparenza di ciò che sta nel mezzo delle cose, nell’eterna disperazione di non poter conoscere il loro principio e la loro fine? Tutte le cose sono uscite dal nulla e portate fino all’infinito. Chi mai seguirà queste strade sorprendenti?
L’autore di queste meraviglie le comprende; nessun altro può farlo.[…]L’uomo contempli dunque la natura intera nella sua alta e piena maestà; distolga lo sguardo dagli oggetti bassi che lo circondano. Volga gli occhi a quella luce splendente messa come lampada eterna a illuminare l’universo; e la terra gli appaia come un punto rispetto all’ampio cerchio descritto da quell’astro, e provi stupore nel fatto che quell’ampio cerchio non è esso stesso che una lievissima traccia rispetto a quello che abbracciano questi astri che ruotano nel firmamento”.
Ma “sentire” Dio vuol anche dire, pensare e vivere in un modo nuovo, dove Gesù è Centro e Modello, poiché in lui solo la Fede, il Pensiero e la Vita si fondono in completa Armonia:
“A Gesù Cristo guardano i due Testamenti:
l’Antico come all’atteso, il Nuovo come al suo modello, tutti e due come al loro centro”.
Vengono anche forniti dei consigli pratici:
“Fare le piccole cose come se fossero grandi, a causa della maestà di Gesù Cristo che le fa in noi e che vive la nostra vita; e le grandi come se fossero piccole e facili, a causa della sua onnipotenza”.
“La Vera religione insegna i nostri doveri, le nostre impotenze (orgoglio e concupiscenza) e i rimedi (umiltà e mortificazione)”.
“Noi soffriamo in proporzione alla resistenza che il vizio, connaturato in noi, oppone alla grazia soprannaturale; il nostro cuore si sente lacerato da sforzi contrari; ma sarebbe ingiusto imputare questa violenza a Dio, che ci attira, invece di attribuirla al mondo, che ci trattiene”.
Va comunque detto che Pascal non ha mai osteggiato la scienza, definendola, nell’ambito che ad essa spetta, sovrana e difendendola da bigottismi e posizioni miopi prese da certi teologi dell’epoca.
Un esempio in grado di avvalorare la sua libertà di pensiero è ritrovabile nella polemica antigesuita, nelle sue 18 lettere denominate Provinciales, dove attacca la morale gesuitica e difende la comunità di Port-Royal accusata dalla chiesa perché in odore di eresia giansenista (pratica messa al bando da Papa Innocenzo X, nel 1653).
L’apologia di Pascal sostiene che la ragione debba essere subordinata all’intuizione ed al cuore, da qui il rifiuto alla teologia che pretende di modellarsi su schemi di tipo matematico.
L’esistenza di Dio non può infatti essere dimostrata in alcun modo razionale, ne tanto meno negata, va percepita e seguita, perché la Fede va intesa come una scelta.
Il problema non è quindi convincere della veridicità della religione cristiana;
ma se aderirvi o meno.
Una delle più ardite e convincenti teorizzazioni pascaliane è quella della “scommessa sull’esistenza di Dio”, una scommessa dove si gioca tutto.
Proprio per l’indimostrabilità della sua esistenza, l’uomo, davanti al divino si trova ad un bivio.
Seguire Dio oppure il mondo?
Il rapporto fra le probabilità che Dio esista o meno, è un rapporto finito, inscrivibile in un numero, proprio per il fatto che non vi è alcuna certezza a riguardo;
si può quindi di volta in volta, argomentare a pro o a contro e variare questa percentuale.
Dove vi è invece un rapporto infinito è nella posta in gioco, Dio (qualora ci fosse) è il Tutto:
Felicità infinita; Beatitudine, Sapienza, Potenza ed Amore infiniti, al cui confronto il mondo rimane ben misera cosa.
Al giocatore, a qualsiasi individuo, conviene quindi puntare su Dio, per il semplice fatto che se vince, è partecipe dell’Infinito;
se perde, non avrebbe perso molto, dato l’effimera durata delle cose mondane.
Oltretutto qualora si puntasse sul mondo, si vivrebbe come sempre si è fatto e l’infelicità che ci spinge alla ricerca di qualcosa in più, perdurerebbe fino alla fine.
"Poiché scegliere bisogna, vediamo ciò che vi interessa di meno.
Voi avete due cose da perdere: il vero e il bene;
e due cose da impegnare nel gioco:
la vostra ragione e la vostra volontà,
la vostra conoscenza e la vostra beatitudine;
e la vostra natura ha due cose da fuggire: l'errore e la miseria. (...)
Valutiamo questi due casi: se guadagnate, voi guadagnate tutto;
se perdete, non perdete niente.
Scommettete dunque che egli esiste, senza esitare".
|
| |
|
La Fede arriverà progressiva, esercitandosi nell’Amore e nelle virtù.
Lungo il suo cammino intellettuale, nella sua esperienza di attento osservatore, Pascal individua due differenti spiriti (modi d’intendere, di cogliere i problemi e percepire la realtà) attivi nell’uomo, che egli definisce come: spirito di geometria (esprit de géométrie) e spirito di finezza (esprit de finesse).
Il primo procede dimostrativamente, è la ragione scientificamente intesa, ed ha come oggetto le cose esteriori; il secondo permette di “sentire” ed intuire le verità, discernere le sfumature basandosi sul sentimento, ed ha per oggetto l’uomo.
Lo spirito di geometria è comunque subordinato allo spirito di finezza, proprio come la ragione lo è al cuore.
Lo spirito di finezza permette di conoscere l’uomo interiormente, nella sua essenza spirituale e questa è la strada per raggiungere la Verità, ed il modo migliore di vivere.
"Bisogna conoscere se stessi; quand’anche non servisse a trovare la verità, giova per lo meno a regolare la propria vita. E non c’è nulla di più giusto".
Ed è proprio grazie ad una vita moralmente più giusta ed equilibrata, regolando i suoi desideri e le sue aspettative, che l’uomo può trovare la giusta dimensione con la quale intraprendere il viaggio verso le Conoscenze più alte.
L’auto-convincimento è vano, se non viene accompagnato dalla costante eliminazione delle passioni.
L’unica forza e grandezza dell’uomo è la sua capacità di riflettere, di pensare e riconoscere la sua pochezza di fronte all’Infinito o alle forze ed elementi della natura, ma in virtù di questa consapevolezza, diviene immenso e partecipe del Divino quando regola la sua vita ed esercita queste sue prerogative.
“L’ uomo non è che una canna, la più fragile di tutta la natura; ma è una canna pensante.
Non c'è bisogno che tutto l'universo s'armi per schiacciarlo: un vapore, una goccia d'acqua basta a ucciderlo. Ma, anche se l'universo lo schiacciasse, l'uomo sarebbe ancor più nobile di chi lo uccide, perché sa di morire e conosce la superiorità dell'universo su di lui; l'universo invece non ne sa niente.
Tutta la nostra dignità consiste dunque nel pensiero.
E' con questo che dobbiamo nobilitarci e non già con lo spazio e il tempo che potremmo riempire. Studiamoci dunque di pensare bene: questo è il principio della morale".
Il 19 agosto del 1662, a soli 39 anni, Pascal muore, in casa della sorella Gilberte.
Lascia in eredità, all’intero genere umano, importanti e fondamentali scoperte scientifiche, ed ancor più preziose intuizioni, che ne fanno un autentico ricercatore e pioniere, tanto delle scienze della fisica, quanto di quelle dello Spirito.
I suoi “Pensieri” sono il limpido testamento, amorevolmente lasciato al genere umano, da un uomo che, con coerenza, ha modellato la sua vita per renderla davvero utile ed esemplare, insegnandoci a vivere nel presente ogni attimo della nostra esistenza, non rimandando al futuro decisioni e speranze.
L’esperienza di Pascal insegna come ogni dolore e tribolazione sia trampolino di lancio verso le più alte vette dello Spirito, la sofferenza va quindi affrontata con la giusta attitudine.
Se il mondo è affanno e tristezza, Dio è Gioia ed Amore, sta a noi, esseri dotati di pensiero, scegliere come dirigere la nostra vita.
Nell’ottocento, il grande scrittore francese Chateaubriand, percependo l’importanza di tali precetti, descriverà la luminosa parabola della vita di Pascal con queste memorabili parole:
"Ci fu un uomo che a 12 anni, con aste e cerchi, creò la matematica;
che a 16 compose il più dotto trattato sulle coniche dall’antichità in poi;
che a 19 condensò in una macchina una scienza che è dell’intelletto;
che a 23 anni dimostrò i fenomeni del peso dell’aria ed eliminò uno dei grandi errori della fisica antica; che nell’età in cui gli altri cominciano appena a vivere, avendo già percorso tutto l’itinerario delle scienze umane, si accorge della loro vanità e volse la mente alla religione; che da quel momento sino alla morte – avvenuta a 39 anni – sempre malato e sofferente, fissò la forma della lingua in cui dovevano esprimersi Bossuet e Racine, diede il modello tanto del motto di spirito più perfetto quanto del ragionamento più rigoroso;
che infine, nei brevi intervalli concessigli dal male, risolse quasi distrattamente uno dei maggiori problemi della geometria e scrisse dei pensieri che hanno sia del divino che dell’umano.
Il nome di questo genio portentoso è Blaise Pascal".
![[SM=g7427]](https://im0.freeforumzone.it/up/0/27/2725709.gif) |
| |
| | | OFFLINE | Post: 11.290 | Registrato il: 03/10/2008
Registrato il: 01/11/2008 | Sesso: Maschile | |
|
La conversione di Oscar Wilde
Intervista allo scrittore e saggista Paolo Gulisano
di Antonio Gaspari
ROMA, martedì, 30 giugno 2009 (ZENIT.org).- Oscar Wilde è fin troppo famoso, ma ben poco conosciuto. L’esteta, il commediografo brillante, l’icona del mondo gay, fu allo stesso tempo un ricercatore inesausto del Bello, del Buono, ma anche e soprattutto di quel Dio che non aveva peraltro mai avversato, dal quale si fece pienamente abbracciare dopo l’esperienza drammatica del carcere.
Wilde arrivò a chiudere il suo itinerario umano in comunione con la Chiesa Cattolica, adempiendo a quello che aveva scritto anni prima: “il Cattolicesimo è la sola religione in cui morirei”.
A rivelare la profonda cattolicità di Wilde è Paolo Gulisano, scrittore e saggista es perto del mondo britannico (è autore di diversi volumi su Tolkien, Lewis, Chesterton e Belloc) che ha appena pubblicato: “Il Ritratto di Oscar Wilde” (Editrice Ancora, pag 190 euro 14).Si tratta di un ritratto a tutto tondo di Oscar Wilde, che rappresenta tutta la complessa personalità, ne evidenzia tutti gli aspetti, andando alla scoperta degli scenari su cui recitò la sua parte nel gran teatro della vita, delle sue passioni, dei suoi interessi, del suo immaginario e della sua attenzione ai problemi sociali, e infine del suo sentimento religioso profondo e autentico.Per meglio conoscere la storia di un commediografo le cui opere vengono rappresentate nei teatri di tutto il mondo, ZENIT ha intervistato Paolo Gulisano.
Lei rintraccia nella figura di Wilde uno spessore ben maggiore di quello comunemente attribuitogli, cioè di un dandy brillante e superficiale, un esteta dalla battuta pronta ma effimera. Viceversa lei tira in ballo nozioni come Bellezza e Verità…
Gulisano: Oscar Wilde rappresenta un mistero non ancora pienamente svelato, un uomo e un artista dalla personalità poliedrica, complessa, ricca. Non solo un anticonformista che amava stupire la conservatrice società dell’Inghilterra vittoriana, ma anche un lucido analizzatore della Modernità con i suoi aspetti positivi e soprattutto inquietanti. Il Ritratto di Dorian Gray è il racconto straordinario dell’uomo moderno che insegue disperatamente un’Eterna Giovinezza, che si pone l’obiettivo utopistico di vincere o perlomeno ingannare la morte. Non solo un’esteta, il cantore dell’effimero, il brillante protagonista dei salotti londinesi, ma anche un uomo che dietro la maschera dell’amoralità si interrogava e invitava a porsi il problema di ciò che fosse giusto o sbagliato, vero o falso, persino nelle sue principali commedie degli equivoci.
Wilde è ancora oggi una icona gay per il celebre processo subito che segnò la fine della sua fortuna. Può riassumere in breve la vicenda giudiziaria ed anche la correzione di prospettiva che lei introduce?
Gulisano: Wilde non può essere definito tout court “Gay”: aveva amato profondamente sua moglie, dalla quale aveva avuto due figli che aveva sempre amato teneramente e ai quali, da bambini, aveva dedicato alcune tra le più belle fiabe mai scritte, quali “Il Gigante egoista” o “Il Principe Felice”. Il processo fu un guaio in cui finì per aver querelato per diffamazione il Marchese di Queensberry, padre del suo amico Bosie, che lo aveva accusato di “atteggiarsi a sodomita”. Al processo Wilde si trovò di fronte l’avvocato Carson, che odiava irlandesi e cattolici, e la sua condanna non fu soltanto il risultato dell’omofobia vittoriana.
Qual è stato il tormentato rapporto tra Wilde e la verità cattolica, rapporto che è un po' il file rouge del suo lavoro?
Gulisano: Il cammino esistenziale di Oscar Wilde può anche essere visto come un lungo e difficile itinerario di conversione al cattolicesimo. Una conversione di cui nessuno parla, e che fu una scelta meditata a lungo, e a lungo rimandata, anche se - con uno dei paradossi che tanto amava- , Wilde affermò un giorno a chi gli chiedeva se non si stesse avvicinando troppo pericolosamente alla Chiesa Cattolica: "Io non sono un cattolico. Io sono semplicemente un acceso papista". Dietro la battuta c’è la complessità della vita che può essere vista come una lunga e difficile marcia di avvicinamento al Mistero, a Dio.
Ci sono molte curiosità a proposito di Wilde. Una è che le figure che determinarono la sua esistenza finirono qu asi tutte per convertirsi...
Gulisano: Esatto: amici come Robbie Ross, Aubrey Beardsley, e addirittura quel John Gray che gli ispirò la figura di Dorian Gray che diventato cattolico entrò anche in Seminario a Roma e divenne un apprezzatissimo sacerdote in Scozia. Infine, anche il figlio minore di Wilde divenne cattolico.
Lei da anni indaga, nei suoi libri, il filo d'oro culturale e religioso che percorre in modo a volte celato, la cristianità anglosassone, da cinque secoli staccata da Roma e per certi versi una centrale mondiale di secolarizzazione e anticattolicità. C'è un disegno in queste sue indagini? Dove trova le motivazioni? Perchè questa ricerca?
Gulisano: L’Inghilterra cattolica ha conosciuto per prima in Europa la persecuzione, la secolarizzazione, il tentativo di emarginare la Fede; per questo ha sviluppato quegli anticorpi spirituali che sono presenti in autori quali Newman, Chesterto n, Tolkien. E possono fornire ancora oggi un utile vaccino contro i mali spirituali del nostro tempo. __________________________________________________
 |
| |
|
|
|
|